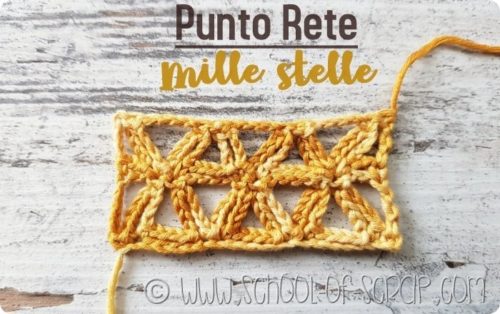Carissimi frequentatori del blog, con questo scritto vi offro una sorta di "summa" che consegue ad un discorso complessivamente affrontato negli ultimi mesi. Abbiamo tentato di precisare e di rendere più nitida una linea interpretativa dei trattati che offra soluzioni di salvezza alla società democratica italiana, alternativa all'attuale rinchiuderla in un ostinato accanimento distruttivo che preclude ormai persino la possibilità di un ritorno al benessere ed ai principi supremi della nostra Costituzione.
Ci auguriamo che, da qualche parte, e in qualche modo, ci ascoltino. Con attenzione, e senza pregiudizi ideologici. Temiamo che ciò risulti quantomeno improbabile.
Ma, in una situazione di emergenza nazionale come quella che stiamo vivendo, e con la prospettiva di ritrovarsi, di qui a pochi mesi, in un'accelerazione del disastro "ce lo chiede l'Europa", abbiamo cercato di fare il "possibile".
Possiamo solo "attivamente" sperare (disperatamente) che "qualcosa" ponga fine all'attuale "sonno della Ragione".
AVVISO DI LETTURA: LO SCRITTO è STATO FATTO IN PREPARAZIONE DI UNA LEZIONE AGLI STUDENTI DELLA LUISS CONSENTITAMI DALL'AMICO CESARE POZZI. DATA LA GRAN MOLE DI ANALISI INTERPRETATIVE RELATIVE A NUMEROSI DATI NORMATIVI, PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE, E' CONSIGLIATA (almeno) UNA DUPLICE LETTURA
1. PARTE PRIMA: L'EQUIVOCO DELLA IMMAGINARIA NATURA SOLIDARISTICA E TUTRICE DELLA PACE ASCRITTA AI TRATTATI EUROPEI.
C'è la diffusa idea, tra i ranghi delle persone che amano l'euro in nome della pace e della apertura delle frontiere alla immigrazione (?), che la globalizzazione esiga una "moneta forte" e, specialmente, "unica", esattamente come la concepiva Mussolini, che peraltro sosteneva il pregio di una moneta forte ("quota 90") arrivandoci da un altro percorso, se vogliamo economicamente più coerente (cioè con un più verosimile mascheramento del favore per il capitale).
Ci auguriamo che, da qualche parte, e in qualche modo, ci ascoltino. Con attenzione, e senza pregiudizi ideologici. Temiamo che ciò risulti quantomeno improbabile.
Ma, in una situazione di emergenza nazionale come quella che stiamo vivendo, e con la prospettiva di ritrovarsi, di qui a pochi mesi, in un'accelerazione del disastro "ce lo chiede l'Europa", abbiamo cercato di fare il "possibile".
Possiamo solo "attivamente" sperare (disperatamente) che "qualcosa" ponga fine all'attuale "sonno della Ragione".
AVVISO DI LETTURA: LO SCRITTO è STATO FATTO IN PREPARAZIONE DI UNA LEZIONE AGLI STUDENTI DELLA LUISS CONSENTITAMI DALL'AMICO CESARE POZZI. DATA LA GRAN MOLE DI ANALISI INTERPRETATIVE RELATIVE A NUMEROSI DATI NORMATIVI, PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE, E' CONSIGLIATA (almeno) UNA DUPLICE LETTURA
1. PARTE PRIMA: L'EQUIVOCO DELLA IMMAGINARIA NATURA SOLIDARISTICA E TUTRICE DELLA PACE ASCRITTA AI TRATTATI EUROPEI.
C'è la diffusa idea, tra i ranghi delle persone che amano l'euro in nome della pace e della apertura delle frontiere alla immigrazione (?), che la globalizzazione esiga una "moneta forte" e, specialmente, "unica", esattamente come la concepiva Mussolini, che peraltro sosteneva il pregio di una moneta forte ("quota 90") arrivandoci da un altro percorso, se vogliamo economicamente più coerente (cioè con un più verosimile mascheramento del favore per il capitale).
Sulla solidità economica, per il benessere dei popoli europei (art.3, par.1 TUE) dell'idea della moneta forte e della inscindibile deflazione (lotta all'inflazione, contabbandata come soluzione ai problemi delle classi lavoratrici) che essa comporta, ed ha in effetti comportato, si sono espressi i più grandi economisti mondiali ed italiani. Sui "problemini" pratici che questa affrettata idea comporti proprio per il livello di occupazione e, conseguentemente, dei salari, abbiamo, illustrato le teorie della neo-macroeconomia classica, evolutasi dal monetarismo e dalla teoria generale dello Stato di von Hayek, nel raccordarle alla dottrina delle banche centrali indipendenti.
Sulla pace tra i popoli quale obiettivo presuntamente perseguibile attraverso l'euro, (o più generalmente con l'applicazione di un trattato congegnato come quello di Maastricht e ss.), si è visto sia cosa comporti l'attuale sistema in termini di esasperata competizione commerciale attraverso i tassi di cambio reale e gli artifici tedeschi mirati a procurarsi una posizione di vantaggio inattaccabile, attraverso una preventiva violazione dei trattati, sia attraverso la successiva imposizione del fiscal compact e del pareggio di bilancio in Costituzione.
I risultati, davanti agli occhi di tutti quelli che li vogliono scorgere, sono equivalenti a quelli di una guerra di colonizzazione (del resto d'Europa), e, nel lungo periodo, non meno devastanti; questi risultati (che il velo di un'affrettata ideologia semplificatrice ad autoassolutoria tende a ignorare), sono complessivamente disastrosi proprio rispetto all'obiettivo di una "crescita equilibrata" e rispetto alle condizioni sociali e di lavoro in cui si trovano a vivere coloro che sono costretti alla "circolazione delle persone" (in quanto cittadini UE) o alla "immigrazione" (art.3, par.2, TUE).
Ma coloro che si ostinano a portare il presunto vessillo pacificatore e solidaristico dell'UE, - senza saperla distinguere, come impone il piano normativo, dalla Unione monetaria, cioè dall'euro, strumento non "costitutivo" della personalità giuridica UE nonchè della stesso status di appartenenza all'Unione, come è palese in base all'art.3, par. 4 del TUE (letto senza infingimenti nel suo senso logico-letterale)-, non conoscono la effettiva disciplina dei Trattati, che li smentisce senza residuo di dubbio.
Il sospetto è, piuttosto, che non li abbiano mai letti e che, in ogni modo, non siano in grado di decifrarne la effettiva portata normativa.
Il sospetto è, piuttosto, che non li abbiano mai letti e che, in ogni modo, non siano in grado di decifrarne la effettiva portata normativa.
L'Europa "fortemente competitiva", di cui parla come principio fondamentale l'art.3, par.3 - sempre accostandolo alla stabilità dei prezzi ed alla connessa e subordinata "piena occupazione" di stampo neo-classico- è, come evidenzia con inesorabile chiarezza scientifica Krugman, quella di una competizione tra Stati, rispondente alla convenienza delle posizioni espressamente antisolidaristiche contenute nel Trattato (artt.123, 124 e 125 TFUE) ed intessuta sulla guerra finanziaria e commerciale di un mercato aperto principalmente alla libera circolazione dei capitali e al dominio politico realizzato tramite l'asservimento della domanda degli Stati "vicini" alla propria produzione industriale e al proprio sistema bancario-finanziario.
Quanto tutto questo abbia a che fare con la pace e con la difesa delle condizioni sociali del lavoro, programmaticamente ricondotto a "merce", è poi evidenziabile nel fatto che, a prescindere dalla enunciazioni "per sentito dire" nonché ossequiose di slogan lanciati senza alcuna considerazione dell'effettivo sistema dei trattati, nella grund-norm dei trattati campeggia la formula, propagandistica e puramente cosmetica, della "economia sociale di mercato" (rammentiamo" fortemente competitiva"), contenuta dell'art.3, par.3, del TUE.
2- IL QUADRO NORMATIVO DEI TRATTATI E LA LORO PORTATA GIURIDICA E MACROECONOMICA.
Sintetizzando, secondo quanto già evidenziato in precedenza, questo è il quadro normativo europeo e il disegno che, in una corretta operazione ermeneutica, se ne ricava:
- in un contesto normativo e istituzionale come quello delineato dai Trattati, nella portata confermata dalle politiche attuative poi seguite univocamente da Commissione e Consiglio, nonchè nei seguenti atti modificativi dei trattati stessi, il principio della "economia sociale di mercato fortemente competitiva" (cardine dell'art.3, par.3), non può riferirsi, sul piano normativo letterale e sistematico, alla instaurazione della concorrenza perfetta, obiettivo neppure larvatamente riconoscibile nella disciplina della concorrenza di cui agli artt.101-106 del TFUE;
- per necessità logica e coerentemente sistematica, tale principio rinvia invece all'applicazione della pura legge della domanda e dell'offerta al mercato del lavoro, proprio perchè è obiettivamente connesso al perseguimento espresso di quella simultanea "stabilità dei prezzi"(equiordinato principio-cardine che si proietta su tutto il resto della disciplina dei Trattati), che vincola alla continuata deflazione salariale, quale strumento principe di controllo dell'inflazione;
- quest'ultimo principio supremo dell'ordine impresso dai trattati, a sua volta, trova immediata spiegazione solo in uno schema programmatico, culminante nel funzionamento inevitabile di qualunque area a cambio fisso governata dal solo istituto di una banca centrale indipendente "pura"unita all'esclusione, espressa e rafforzata, di ogni forma di trasferimento fiscalizzato tra i diversi Stati partecipanti all'Unione monetaria stessa(artt.123-125 TFUE);
- tale configurazione normativa esplicita ed inequivocabile determina l'istituzionalizzazione di una competizione tra Stati in forma di reciproca lotta mercantilistica, fondata cioè sul "merito" dell'acquisizione di porzioni crescenti della domanda altrui;
- ciò al punto che i criteri attuativi dello schema dei Trattati tollerano un surplus delle partite correnti, per ciascuno Stato, nella ragguardevole misura del 6% del relativo PIL, senza prevedere un efficace sistema sanzionatorio, adeguatamente correttivo,(come invece si verifica nel caso dell'indebitamento pubblico "eccessivo"), per la violazione di tale limite (già in sè equivalente a un'ampia licenza a perseguire la competizione mercantilistica);
- a coronamento ulteriore di queste conclusioni, v'è la conferma della risibile "clausola solidaristica" dell'art.222 del TFUE, attivabile nel limitato caso di "attacco terroristico" e di "calamità naturale o provocata dall'uomo", ma sempre nei limiti delle "disponibilità" di bilancio dell'UE, e fatta salva, con una certa ovvietà la (comunque esistente) facoltà del paese "colpito" di richiedere "assistenza" agli altri Stati membri; questi, peraltro, non sono tenuti a prestarla, se non sul piano della propria discrezionale autonomia negoziale di diritto internazionale, secondo uno schema che, sul piano logico-giuridico, pone gli Stati-membri nella stessa posizione discrezionale di qualunque altro Stato della comunità internazionale (non appartenente all'Unione).
Ora di fronte a queste evidenze normative, risultanti dai principi-cardine del massimo livello del diritto europeo, non è chi non veda come sia del tutto fuori luogo associare i trattati stessi, e in modo ancor più evidente, la moneta unica, al perseguimento di una qualunque finalità di "pace" e di solidarietà tra i popoli dell'Unione.
Sulla puntuale rispondenza di tale formula alle mire obiettivamente occultate dell'"ordoliberismo", propugnato prima dalla Thatcher (e ben gradito a Pinochet), abbiamo pure acquisito la fonte diretta della sua orchestrazione strategica all'interno della costruzione della "grande società" di von Hayek.
Ora von Hayek, non è identificabile come il male assoluto, ma, nondimeno, aderire ad una visione così fortemente liberista, per totale precomprensione (sarebbe da dire "rimozione") circa la sua influenza decisiva sulla costruzione europea, è obiettivamente inconciliabile non solo con l'enunciazione di un'Europa portatrice di "pace e solidarietà", ma proprio con il riconoscimento dei supremi valori sostanziali della Costituzione ancora vigente in Italia.
3. L'ADESIONE ALLA DISTINTA "UNIONE MONETARIA ED ECONOMICA" COME ELEMENTO NON COSTITUTIVO DELLO STATUS DI PAESE MEMBRO DELL'UNIONE: ANALISI ALLA STREGUA DEI PRINCIPI NORMATIVI DEI TRATTATI.
Fatte queste premesse che rinviano a un intero percorso che si snoda lungo le fonti sopra citate, ci vorremmo soffermare sulla "strana" convinzione che l'euro coincida con l'Europa, o meglio con la Unione europea, fino al punto di sostenere che rinunciare ad esso, mera opzione relativa al sistema monetario adottabile all'interno di tale organizzazione internazionale, implicherebbe il ritorno alle contese tra Stati, magari guerreggiate, ed alla fuoriuscita dalla stessa UE.
Fatte queste premesse che rinviano a un intero percorso che si snoda lungo le fonti sopra citate, ci vorremmo soffermare sulla "strana" convinzione che l'euro coincida con l'Europa, o meglio con la Unione europea, fino al punto di sostenere che rinunciare ad esso, mera opzione relativa al sistema monetario adottabile all'interno di tale organizzazione internazionale, implicherebbe il ritorno alle contese tra Stati, magari guerreggiate, ed alla fuoriuscita dalla stessa UE.
Ciò è giuridicamente errato e frutto di una alterata comprensione del testo dei trattati.
Si è già esaminata in un precedente lavoro l'ipotesi di "recesso dall'Unione" di cui all'art.50 del TUE, evindenziando come la norma sia riferibile a una clausola "speciale" di disciplina dell'ordinario istituto del recesso "sine causa" (cioè frutto di un'autonoma decisione politica dello Stato interessato), quale previsto, in termini generali, dal diritto dei trattati contenuto nella Convenzione di Vienna.
Questa ipotesi, peraltro, a ben vedere, conferma che il recesso dall'Unione, con l'effetto di far cessare lo status di parte contraente-aderente del trattato, riguarda lo status specifico di Stato-membro e pone capo ad una valutazione più complessiva che implica il libero apprezzamento politico della convenienza a rimanere vincolato al quadro socio-economico dei trattati. Questo quadro, però, va subito precisato, non implica, di per sè, quel livello più intenso di vincolo e di adeguamento dell'ordinamento interno implicato dalla successiva ed autonoma adesione all'Unione monetaria.
Passeremo perciò in rassegna il dato positivo delle clausole dei trattati.
Quella prioritariamente indicativa è il già citato art.3, par.4, del TFUE, cui, per la sua collocazione, è da attribuire natura di principio-fonte al vertice della definizione del problema.
4- LA DISCIPLINA POSITIVA DEI TRATTATI RELATIVA ALL'ADESIONE ALL'UNIONE MONETARIA.
l'art.3, par.4, recita "L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro". Da ciò possono ritrarsi alcune importanti conseguenze:
1) la istituzione dell'unione monetaria procede, come necessaria implicazione dello stesso dato letterale, come atto successivo a quello del pieno perfezionamento del trattato sull'Unione che, nel dargli vita secondo apposite procedure, presuppone di agire già nella sua compiuta ed indipendente soggettività. La configurabilità giuridica di quest'ultima, dunque, prescinde dalla istituzione della "unione economica e monetaria", sia nel senso che non è elemento costitutivo della sua "personalità giuridica" (e infatti, nell'attribuirla, l'art.47 TUE non vi fa cenno), sia nel senso, strettamente conseguenziale, che lo status di membro dell'Unione non implica l'adesione a tale fase di attuazione programmatica del trattato. Quest'ultimo, dunque, anteriormente a tale atto, configura già un compiuto ordinamento pattizio internazionale (si tende a dire "sovranazionale", per sottolineare la controversa prevalenza delle sue disposizioni sulle norme interne degli Stati-membri);
2) dunque l'unione monetaria, come atto imputabile ad un'"Unione", già dotata di presupposta personalità giuridica autolegittimantesi al di fuori dell'esistenza dell'unione monetaria stessa, comporta che l'organizzazione internazionale "Unione"non preveda nel suo "statuto" nè abbia successivamente previsto, rispetto al progressivo compimento di questa sua attività, alcun espresso obbligo di partecipazione a carico degli Stati membri, a conferma che lo status di paese aderente all'Unione non sottointenda l'adesione alla moneta come elemento costitutivo dello status stesso;
3) eloquente corollario, pienamente in linea con quanto precede, è che gli artt.139 e 140 del TFUE prevedono la figura deli "Stati con deroga", attualmente una decina, definiti come gli STATI MEMBRI "per i quali il Consiglio non ha deciso che soddisfino le condizioni per l'adozione dell'euro";
4) nè vale a rendere meno significativa la disciplina di tali artt.139-140, l'essere inseriti nel capo 5 del TFUE sotto l'intitolazione "Disposizioni transitorie": il nomen juris, in una normale operazione interpretativa recede di fronte al dato sistematico delineato dalle prevalenti disposizioni di principio finora illustrate:
- una norma è transitoria, al di là della partizione nominalistica della fonte in cui è collocata, in quanto sia soggetta ad un termine normativo, e quindi vincolante, di sua applicabilità. Ciò non si verifica per detti artt.139-140, dato che nessun termine "finale" risulta essere posto rispetto alla conclusione del procedimento di adesione generalizzata all'unione monetaria di tutti gli Stati-membri dell'Unione;
- le norme stesse non risultano transitorie anche alla luce dell'applicazione pratica che ne è scaturita; ciò in quanto regolano status ormai stabilmente compresenti nell'Unione - cioè paesi "con deroga" che permangono indefinitamente in tale loro condizione riservandosi, ad libitum , se attivare o meno la procedura di adesione. Per di più, le stesse procedure, sempre per la mancanza di un qualunque termine finale vincolante, finiscono per disciplinare, in via generale ed astratta, un allargamento dell'unione monetaria ad applicazione indefinitamente "ripetibile"(per ogni caso che si possa presentare in astratto e al di là di ogni limite di tempo).
- e non poteva essere diversamente, dato che, come abbiamo visto, l'art.3, par.4, non pone alcun termine ed alcuna obbligatorietà della partecipazione aal'UEM che, piuttosto, come risulta evidente, sono gli stessi artt.139-140 ad escludere come oggetto di obbligo, configurando una complessa procedura in cui, non solo in fase di attivazione, ma anche nella stessa fase finale di "ammissione", presuppone sempre la libera iniziativa e prestazione del consenso del Paese-membro interessato . Ciò si desume agevolmente non solo dal par.1 dello stesso art.140, relativo alla previsione di una richiesta "attivativa" (risalente all'operatività di Maastricht o successiva ai trattati modificativi), richiesta, liberamente manifestata, implicitamente imprescindibile, ma anche dal successivo par.3, in virtù del quale l'atto finale "ammissivo" nell'unione monetaria è obbligatoriamente adottato dal Consiglio "all'unanimità degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dello Stato membro in questione". Tale Stato richiedente, quindi, anche avendo positivamente superato lo scrutinio, previsto al par.2, relativo all'osservanza dei criteri di convergenza (posti dal par.1), mantiene intatta la propria libertà , di adesione o meno all'euro, fino alla fase deliberativa definitiva, potendo semplicemente far mancare il suo consenso finale e la conseguente prescrtta unanimità complessiva (pur avendo appunto superato l'esame di convergenza deliberato dal Consiglio);
- e non poteva essere diversamente, dato che, come abbiamo visto, l'art.3, par.4, non pone alcun termine ed alcuna obbligatorietà della partecipazione aal'UEM che, piuttosto, come risulta evidente, sono gli stessi artt.139-140 ad escludere come oggetto di obbligo, configurando una complessa procedura in cui, non solo in fase di attivazione, ma anche nella stessa fase finale di "ammissione", presuppone sempre la libera iniziativa e prestazione del consenso del Paese-membro interessato . Ciò si desume agevolmente non solo dal par.1 dello stesso art.140, relativo alla previsione di una richiesta "attivativa" (risalente all'operatività di Maastricht o successiva ai trattati modificativi), richiesta, liberamente manifestata, implicitamente imprescindibile, ma anche dal successivo par.3, in virtù del quale l'atto finale "ammissivo" nell'unione monetaria è obbligatoriamente adottato dal Consiglio "all'unanimità degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dello Stato membro in questione". Tale Stato richiedente, quindi, anche avendo positivamente superato lo scrutinio, previsto al par.2, relativo all'osservanza dei criteri di convergenza (posti dal par.1), mantiene intatta la propria libertà , di adesione o meno all'euro, fino alla fase deliberativa definitiva, potendo semplicemente far mancare il suo consenso finale e la conseguente prescrtta unanimità complessiva (pur avendo appunto superato l'esame di convergenza deliberato dal Consiglio);
- e dunque, una procedura relativa ad una fase attuativa del trattato attivabile su richiesta dello Stato membro, ad adesione non obbligatoria in conseguenza di tale status, e non soggetta a termine finale, configura semmai una disciplina "a regime", cioè stabilmente devoluta a consentire l'ampliamento della stessa unione monetaria;
/div>
5) l'unione monetaria, dunque, è un istituto "auspicato" ma non giuridicamente costitutivo dell'Unione europea, risultando configurato, sotto ogni profilo, come conseguenza di un provvedimento ampliativo "eventuale", di uno status autonomamente sussistente nella sua pienezza (quello cui si riferisce, semmai, il già visto recesso ex art.50 del TUE. La natura di provvedimento ampliativo implica, per corollario logico necessario, che esso sia disciplinato alla stregua dell'attribuzione "concessoria" di un quid pluris "vantaggioso", un bene della vita aggiuntivo, che può spettare al richiedente solo a condizione che attivi la relativa procedura e presti il suo consenso fino all'adozione del provvedimento costitutivo di tale status aggiuntivo (a quello di membro dell'Unione);
I) la sottrazione al regime sanzionatorio per "disavanzo eccessivo" previsto dall'art.126 del TFUE, come espressamente prevede l'art.139, par.2, lettera b);
II) la sottrazione agli indirizzi di massima per le politiche economiche concernenti, ai sensi dell'art.121, par.2, i soli paesi dell'area-euro, come prevede lo stesso art.139, par.2, lettera a), nonchè la simultanea sottrazione a tutti gli altri meccanismi di vincolo previsti dalle restanti lettere dello stesso par.2;
III) la sottrazione allo stesso obbligo di incondizionato adeguamento della disciplina della propria banca centrale agli artt. 130 e 131 del TFUE, nonchè agli stessi limiti di azione sanciti dall'art.123 del TFUE (il ben noto divieto di acquisti diretti di titoli del debito pubblico), dato che il mancato o incompleto adeguamento dello Statuto della banca centrale al regime dei trattati è esclusivamente "sanzionato" con la preclusione, per difetto del primo dei "criteri di convergenza", alla "ammissione" nell'unione monetaria, cioè proprio a quel meccanismo a cui, lo Stato membro ridivenuto "con deroga", si è appena sottratto. Eloquente esempio di ciò è la Bank of England, tra l'altro, una delle più importanti non solo all'interno della stessa Unione ma dell'intero panorama finanziario mondiale.
IV) la sottrazione all'osservanza immediata dei più stringenti obblighi fiscali previsti dal "TRATTATO SULLA STABILITÀ, SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA" c.d. "fiscal compact", che infatti al suo art.14, par.5, prevede, in termini non equivocabili: "Il presente trattato si applica alle parti contraenti con deroga, quali definite all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o con esenzione, di cui al protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato ai trattati dell'Unione europea, che hanno ratificato il presente trattato, dalla data di decorrenza degli effetti della decisione di abrogazione di tale deroga o esenzione, a meno che la parte contraente interessata dichiari che intende essere vincolata, in tutto o in parte, dalle disposizioni dei titoli III e IV del presente trattato prima di tale data"
Non vanno perciò sottaciuti, in questo quadro, gli enormi vantaggi che ne scaturirebbero proprio per un recupero della capacità negoziale italiana con riguardo alla revisione del quadro complessivo dei trattati.
L'Italia, mantenutasi a pieno titolo nella qualità di uno dei più importanti Stati membri dell'Unione, potrebbe far valere con effettività le sue posizioni verso un rilancio del quadro cooperativo e solidaristico dell'Europa, col superamento dei difetti genetici e funzionali che oggi rendono sempre più insostenibile l'unione monetaria.
Questo in quanto potrebbe nuovamente dare il suo tradizionale apporto, di fondamentale paese "fondatore" della costruzione europea, senza essere astretta dai vincoli e dalle sanzioni che oggi non solo smorzano sul nascere la sua autonomia negoziale, ma la costringono ad inseguire politiche economico-fiscali eteroimposteche, dati i difetti macroscopici di impostazione (monetarista e liberista) della moneta unica, le impediscono di promuovere, sui trattati stessi, quelle modifiche esponenziali dei principi inviolabili del proprio ordinamento costituzionale.
Con ciò potendosi anche, nella permanenza della qualità di Stato membro, e tuttavia non invasiva della sua autonomia monetaria e fiscale, correggere la contrarietà sempre più pronunciata dell'applicazione dei trattati ai prerequisiti di loro recepimento post dall'art.11 Cost.
, quali illustrati nella prima parte.
5) l'unione monetaria, dunque, è un istituto "auspicato" ma non giuridicamente costitutivo dell'Unione europea, risultando configurato, sotto ogni profilo, come conseguenza di un provvedimento ampliativo "eventuale", di uno status autonomamente sussistente nella sua pienezza (quello cui si riferisce, semmai, il già visto recesso ex art.50 del TUE. La natura di provvedimento ampliativo implica, per corollario logico necessario, che esso sia disciplinato alla stregua dell'attribuzione "concessoria" di un quid pluris "vantaggioso", un bene della vita aggiuntivo, che può spettare al richiedente solo a condizione che attivi la relativa procedura e presti il suo consenso fino all'adozione del provvedimento costitutivo di tale status aggiuntivo (a quello di membro dell'Unione);
6) ne discende ulteriormente, che l'intero regime giuridico dell'ammissione (ad adesione coessenziale e costitutiva in quanto espressa dallo Stato interessato) divenga quello proprio degli atti c.d. ampliativi. E cioè esso risulta costantemente mantenibile a condizione del protrarsi del consenso coessenziale del paese "beneficiato". Come una licenza-autorizzazione edilizia ovvero come una licenza per la vendita degli alcolici, il titolare avrà sempre e comunque, in omaggio alla libera disponibilità volontaria del bene "aggiuntivo" attribuitogli dall'Autorità concedente, la facoltà di rinunciarvi e di sottrarsi in tal modo al complesso dei controlli e sanzioni che condizionano, nell'ambito della funzione pubblicistica del provvedimento ampliativo, il successivo rapporto di durata con la stessa Autorità concedente;
7) ciò, va ribadito, configura tale libera disponibilità come principio di civiltà giuridica comune alla nazioni civili e non ha bisogno, per poter essere affermato, della una esplicita previsione di una procedura eguale e contraria per poter essere ammessa: la cessazione degli effetti dell'atto ampliativo consegue naturalmente al contrarius consensus del "beneficiato", poichè, ove si negasse ciò, l'atto ampliativo, con la sua base "causale" di necessaria e perdurante prestazione del consenso da parte dell'istante, si trasformerebbe diversamente in atto ablativo, cioè espropriativo proprio di quella stessa volontà dispositiva dei propri interessi insita obiettivamente nel sistema degli artt.139-140;
8) mentre, d'altra parte, sarebbe contrario allo jus cogens contenuto nella Convenzione di Vienna, la prestazione di un consenso irretrattabile, rispetto ad una situazione di durata che è pur sempre necessariamente soggetta alla regola di diritto internazionale generale del "rebus sic stantibus". Circostanze sopravvenute e non pienamente previste e prevedibili dalle parti: tipicamente una prassi applicativa dei trattati, praeter ac contra legem, intesa ex bona fide, che renda insostenibile il mantenimento dell'insieme congiunto dei "criteri di convergenza". Cioè, poi, esattamente la situazione che, come ci dicono gli evidenti dati macroeconomici sugli squilibri commerciali, e conseguentemente fiscali, venutisi a creare nell'ambito dell'unione monetaria, ci troviamo oggi a fronteggiare.
4- LA FUORIUSCITA DAL QUADRO UEM COME RIAFFERMAZIONE DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE PREVISTA DAGLI STESSI TRATTATTI E COME INCENTIVAZIONE DEL LIBERO PROCESSO NEGOZIALE "VERSO UNA NUOVA EUROPA".
La conseguenza di tutto quanto sopra illustrato, dunque, è che non soltanto un paese può direttamente e liberamente revocare il proprio consenso costitutivo, secondo lo stesso regime di adesione contenuto nei trattati, del suo status di "paese membro la cui moneta è l'euro", ma tale autonoma decisione, pienamente in linea col regime giuridico dei trattati, pone capo, senza alcun dubbio, alla conservazione della piena qualità di Stato membro.
La conseguenza di tutto quanto sopra illustrato, dunque, è che non soltanto un paese può direttamente e liberamente revocare il proprio consenso costitutivo, secondo lo stesso regime di adesione contenuto nei trattati, del suo status di "paese membro la cui moneta è l'euro", ma tale autonoma decisione, pienamente in linea col regime giuridico dei trattati, pone capo, senza alcun dubbio, alla conservazione della piena qualità di Stato membro.
A tale Stato, peraltro, si applicherà automaticamente la disciplina prevista, sotto il profilo delle politiche monetarie ed economico-fiscali, per gli Stati "con deroga". Essa comporta:
I) la sottrazione al regime sanzionatorio per "disavanzo eccessivo" previsto dall'art.126 del TFUE, come espressamente prevede l'art.139, par.2, lettera b);
II) la sottrazione agli indirizzi di massima per le politiche economiche concernenti, ai sensi dell'art.121, par.2, i soli paesi dell'area-euro, come prevede lo stesso art.139, par.2, lettera a), nonchè la simultanea sottrazione a tutti gli altri meccanismi di vincolo previsti dalle restanti lettere dello stesso par.2;
III) la sottrazione allo stesso obbligo di incondizionato adeguamento della disciplina della propria banca centrale agli artt. 130 e 131 del TFUE, nonchè agli stessi limiti di azione sanciti dall'art.123 del TFUE (il ben noto divieto di acquisti diretti di titoli del debito pubblico), dato che il mancato o incompleto adeguamento dello Statuto della banca centrale al regime dei trattati è esclusivamente "sanzionato" con la preclusione, per difetto del primo dei "criteri di convergenza", alla "ammissione" nell'unione monetaria, cioè proprio a quel meccanismo a cui, lo Stato membro ridivenuto "con deroga", si è appena sottratto. Eloquente esempio di ciò è la Bank of England, tra l'altro, una delle più importanti non solo all'interno della stessa Unione ma dell'intero panorama finanziario mondiale.
IV) la sottrazione all'osservanza immediata dei più stringenti obblighi fiscali previsti dal "TRATTATO SULLA STABILITÀ, SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA" c.d. "fiscal compact", che infatti al suo art.14, par.5, prevede, in termini non equivocabili: "Il presente trattato si applica alle parti contraenti con deroga, quali definite all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o con esenzione, di cui al protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato ai trattati dell'Unione europea, che hanno ratificato il presente trattato, dalla data di decorrenza degli effetti della decisione di abrogazione di tale deroga o esenzione, a meno che la parte contraente interessata dichiari che intende essere vincolata, in tutto o in parte, dalle disposizioni dei titoli III e IV del presente trattato prima di tale data"
Non vanno perciò sottaciuti, in questo quadro, gli enormi vantaggi che ne scaturirebbero proprio per un recupero della capacità negoziale italiana con riguardo alla revisione del quadro complessivo dei trattati.
L'Italia, mantenutasi a pieno titolo nella qualità di uno dei più importanti Stati membri dell'Unione, potrebbe far valere con effettività le sue posizioni verso un rilancio del quadro cooperativo e solidaristico dell'Europa, col superamento dei difetti genetici e funzionali che oggi rendono sempre più insostenibile l'unione monetaria.
Questo in quanto potrebbe nuovamente dare il suo tradizionale apporto, di fondamentale paese "fondatore" della costruzione europea, senza essere astretta dai vincoli e dalle sanzioni che oggi non solo smorzano sul nascere la sua autonomia negoziale, ma la costringono ad inseguire politiche economico-fiscali eteroimposteche, dati i difetti macroscopici di impostazione (monetarista e liberista) della moneta unica, le impediscono di promuovere, sui trattati stessi, quelle modifiche esponenziali dei principi inviolabili del proprio ordinamento costituzionale.
Con ciò potendosi anche, nella permanenza della qualità di Stato membro, e tuttavia non invasiva della sua autonomia monetaria e fiscale, correggere la contrarietà sempre più pronunciata dell'applicazione dei trattati ai prerequisiti di loro recepimento post dall'art.11 Cost.