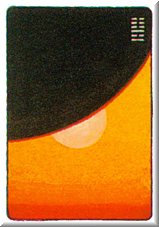
MING- I: L'OTTENEBRAMENTO DELLA LUCE
1. Un breve interludio storico-empirico (d'altra parte qui curiamo l'ipotesi frattalica...), in attesa di affrontare la madre di tutte le questioni "funditus" (sempre nel nostro piccolo, beninteso), e cioè il problema dell'aderenza del modello costituzionale alla "anima" politica del popolo italiano (in termini di destra-sinistra, almeno come punto di partenza).
2. La notazione storico-empirica, (che come vedrete si collega molto da vicino alla "madre di tutte le questioni") potrebbe essere così formulata (disclaimer: ogni riferimento alla realtà odierna è puramente casuale):
a) il liberismo, anche in quella forma di sua "novazione nella continuità della sostanza" che è il neo-liberismo, aborrisce in modo teorico e dichiarato, l'uso diretto della violenza (se non altro perchè teme "l'effetto pretoriani") e, prima ancora, forme di politica connotate (e denominate) formalmente in modo tale da condurre a conflitti violenti nell'ordine sociale, dato che tale conflittualità esaperata contraddice il postulato della "doppia verità";
b) infatti, quest'ultimo, in termini molto pratici, è un metodo di governo che privilegia il richiamo ad un'"alata" moralità, basata su valori generalissimi: primo una "libertà dell'individuo" quale operatore economico razionale ed integerrimo, contrapposto alla sfera pubblica radice di ogni corruzione. Questi valori determinano un'etica pubblica unilaterale, espressa totalmente in accuse muovibili allo Stato.
Esso, come apparato rappresentativo della comunità generale ne viene, quindi, delegittimato nella sua rappresentatività al fine di rafforzare la riduzione della società alle dinamiche (e alle forze prevalenti) del "mercato";
c) poichè la "doppia verità", (così manifestata in un programma politico incontestabile), dissimula la risoluzione del conflitto sociale in favore delle forze prevalenti sul mercato (come evidenzia Galbraith), il processo che ne viene avviato è però inevitabilmente portatore di un crescente autoritarismo, tanto più forte e rapido quanto più si disgregano i partiti di massa, che riflettono l'assetto democratico della risoluzione del conflitto sociale;
d) ne discende che più si afferma un ordinamento neo-liberista più l'assottigliarsi del principio di legalità, fondato sulla legittimazione costituzional-democratica dello Stato, induce la riduzione dei diritti e degli istituti costituzionali a "diritto flessibile" e a degradare le relative norme a "concetto indeterminato", soggetto ai rapporti di forza che prevalgono nel conflitto sociale: ergo, la prima onda di impatto di tale opacità sopravvenuta delle garanzie e dei diritti costituzionali investe proprio la libertà dell'informazione e dell'espressione del libero pensiero (art.21 Cost.).
3. Non sarebbe infatti possibile mantenere, al tempo stesso, la eguaglianza sostanziale, di cui la libertà di informazione è strumento essenziale (in teoria), simultaneamente alla negazione della rigidità della legalità costituzionale, cioè del suo essere fonte suprema e inderogabile di diritto. O si rende "eticamente" superiore l'ordine dei mercati o si tutela l'esistenza di una fonte, la Costituzione, posta per sua funzione di garanzia, al di sopra della politica (divenuta coincidente con le esigenze del mercato) e dei suoi rapporti di forza.
4. Insomma, il trilemma di Rodrik, in termini ancor più generali rispetto all'assetto globalizzato dell'economia, può essere anche espresso come incompatibilità simultanea di Costituzioni democratiche "rigide" (cioè quale fonte inderogabile della sovranità), affermazione delle libertà esclusivamente legittimate dalle leggi del mercato e, "tertium", affermazione delle libertà e dei diritti strumentali alla legalità costituzionale: parliamo di "libertà di stampa", certezza del diritto sanzionatorio, indipendenza della magistratura e imparzialità dell'apparato governo-amministrazione; dunque non dei diritti-fine di tipo sociale, che sarebbero in partenza sacrificati come primo obiettivo del paradigma liberista.

5. Il processo di affermazione del neo-liberismo quindi svuota inevitabilmente i diritti di garanzia (intesi in senso lato), proprio come conseguenza della irrilevanza dei diritti sociali allorchè questi siano costituzionalizzati, e conduce alla informalizzazione degli stessi diritti "civili"tradizionali (o libertà negative: "libertà da...").
In altri termini, esemplificativi, dall'affermazione del fascismo, inizialmente acclamato dai liberisti come restaurazione di un ordine "naturale" dell'economia di mercato", si arriva al delitto Matteotti e alla tardiva presa di distanze e, infine, alla...qualunque (leggi razziali...).
Chiunque, non essendosi opposto inizialmente a questa deriva inevitabile, si trovi poi a lamentarsene, è quantomeno "imprevidente". Com'è già accaduto in Italia, meno di 100 anni fa.