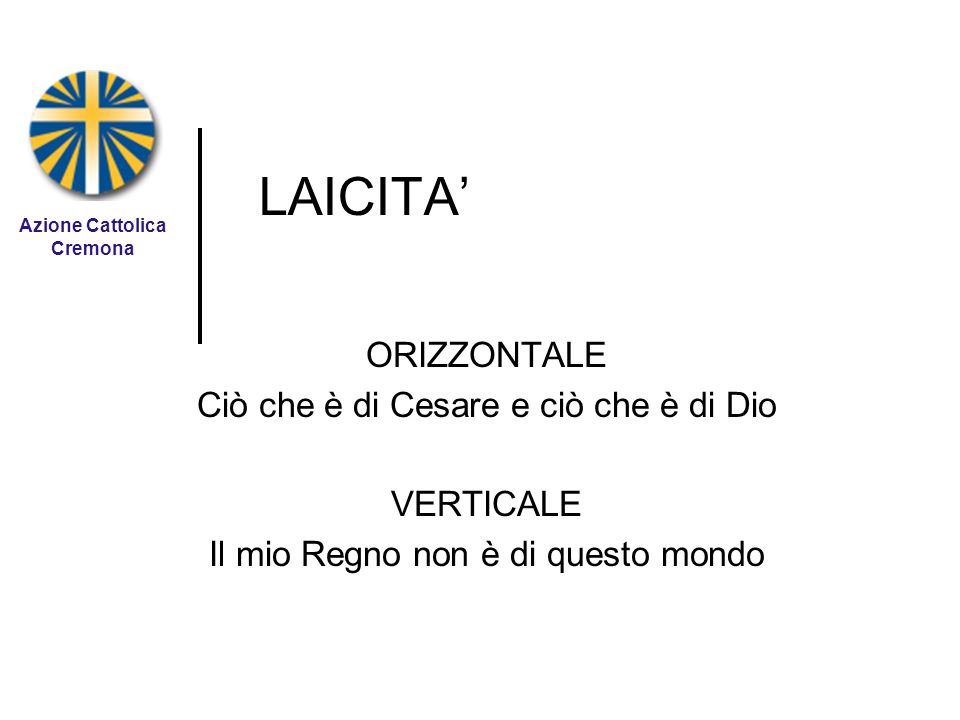
1. Nel post precedente, avevamo fatto riferimento, a titolo esemplificativo, al paragrafo n.53 della Esortazione papale, riportandone il testo.
Per connotare questa denuncia di crescente esclusione ed emarginazione, nella sua novità alienante e disumana, dobbiamo necessariamente supporre che il Santo Padre abbia in precedenza compiuto una sua riflessione sulla natura dei rapporti sociali che si è andata affermando negli ultimi decenni, cercando, forse, di individuare le scelte economiche ed istituzionali che ne sono alla base.
Che sia così, e non sarebbe logico ipotizzare diversamente, se ne avrebbe conferma anche nel precedente paragrafo 52.
2. Nel complesso, la risposta a queste complesse domande, il Papa pare ricercarla nella confluenza degli effetti del progresso tecnologico innestata su un atteggiamento umano che non risulta, peraltro, attribuito a precisi attori delle dinamiche sociali.
Per esclusione (logica), questo atteggiamento non dovrebbe essere imputabile a coloro che risultano "esclusi" e ridotti ad "avanzi".
Ma quando un essere umano sia effettivamente identificabile in questa condizione non è del tutto chiaro: e nemmeno è chiaro, perciò, il meccanismo che rende obiettivamente sempre più vasta la categoria degli "avanzi".
Se si avesse riguardo alla condizione di immigrato economico (o da altre cause di disperazione materiale), nonché di disoccupato senza alcuna protezione sociale, infatti, come il Pontefice pare esplicitamente sottolineare, sarebbe inevitabile considerare che a tale condizione sono ormai esposti settori di popolazione in crescita vertiginosa; anche, e specialmente, nell'(ormai ex) opulento Occidente.
Dunque, sempre sul piano logico, deducibile dalle parole del Papa, non dovrebbero essere gli attuali e, sempre più, potenziali "scarti" i responsabili di tale atteggiamento ma, sempre dedudendo dalle sue parole, "l'economia che uccide" ("Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita").
3. Ergo, sebbene in modo indiretto, il Papa sembra volersi riferire a coloro che prendono le decisioni fondamentali a riflessi collettivi in questo settore; l'alternativa infatti, sarebbe quella di attribuire una complicità, psicologica e culturale, nella propria riduzione ad "avanzi", di coloro che non sono realmente in grado di influire su queste decisioni.
Questa, pure, risulterebbe un'ipotesi di "complicità eteroindotta e...autolesionistica" che è ampiamente indagabile, ma che presuppone l'analisi del fenomeno del rigido condizionamento mediatico e culturale, promosso dall'oligarchia, che induce i danneggiati a invocare la propria distruzione appoggiando i controllori del processo politico-economico: ma è la diretta individuazione di un oligarchia e del suo modus operandi che non è ritrovabile nelle parole del Pontefice.
Obiettivamente, infatti, nel contesto del discorso svolto, il Papa non risulta voler fare una tale generalizzata colpevolizzazione di massa di vittime e carnefici.
Per esclusione (logica), questo atteggiamento non dovrebbe essere imputabile a coloro che risultano "esclusi" e ridotti ad "avanzi".
Ma quando un essere umano sia effettivamente identificabile in questa condizione non è del tutto chiaro: e nemmeno è chiaro, perciò, il meccanismo che rende obiettivamente sempre più vasta la categoria degli "avanzi".
Se si avesse riguardo alla condizione di immigrato economico (o da altre cause di disperazione materiale), nonché di disoccupato senza alcuna protezione sociale, infatti, come il Pontefice pare esplicitamente sottolineare, sarebbe inevitabile considerare che a tale condizione sono ormai esposti settori di popolazione in crescita vertiginosa; anche, e specialmente, nell'(ormai ex) opulento Occidente.
Dunque, sempre sul piano logico, deducibile dalle parole del Papa, non dovrebbero essere gli attuali e, sempre più, potenziali "scarti" i responsabili di tale atteggiamento ma, sempre dedudendo dalle sue parole, "l'economia che uccide" ("Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita").
3. Ergo, sebbene in modo indiretto, il Papa sembra volersi riferire a coloro che prendono le decisioni fondamentali a riflessi collettivi in questo settore; l'alternativa infatti, sarebbe quella di attribuire una complicità, psicologica e culturale, nella propria riduzione ad "avanzi", di coloro che non sono realmente in grado di influire su queste decisioni.
Questa, pure, risulterebbe un'ipotesi di "complicità eteroindotta e...autolesionistica" che è ampiamente indagabile, ma che presuppone l'analisi del fenomeno del rigido condizionamento mediatico e culturale, promosso dall'oligarchia, che induce i danneggiati a invocare la propria distruzione appoggiando i controllori del processo politico-economico: ma è la diretta individuazione di un oligarchia e del suo modus operandi che non è ritrovabile nelle parole del Pontefice.
Obiettivamente, infatti, nel contesto del discorso svolto, il Papa non risulta voler fare una tale generalizzata colpevolizzazione di massa di vittime e carnefici.
Dunque, una qualche identificabilità di coloro che adottano questo atteggiamento, causativo della "esclusione" sociale in termini così totalizzanti e irredimibili, - una identificabilità indiretta e al di fuori della esplicita denuncia della stessa esistenza di una oligarchia-, è oggettivamente affidato, dal Papa, a un processo indiretto di derivazione logica.
4. Facendo un salto concettuale e lessicale, ma non arbitrario, (in base al principio dell'esclusione delle premesse alternative da scartare, per necessaria incompatibilità logica con le conclusioni esplicite assunte nel discorso), dovremmo ragionevolmente identificare tali responsabili in coloro che hanno promosso la restaurazione istituzionale del capitalismo sfrenato (che, come abbiamo visto, in Europa ha assunto la forma dei Trattati UE e, in particolare, della moneta unica).
4. Facendo un salto concettuale e lessicale, ma non arbitrario, (in base al principio dell'esclusione delle premesse alternative da scartare, per necessaria incompatibilità logica con le conclusioni esplicite assunte nel discorso), dovremmo ragionevolmente identificare tali responsabili in coloro che hanno promosso la restaurazione istituzionale del capitalismo sfrenato (che, come abbiamo visto, in Europa ha assunto la forma dei Trattati UE e, in particolare, della moneta unica).
Più che insistere su tale cornice istituzionale, - che abbiamo cercato di focalizzare proprio in contrapposizione a quella, ben diversa, delle Costituzioni democratiche del welfare e dei diritti “attivi” della persona -, ci pare interessante evidenziare che è proprio in tale “restaurazione” che si ritrova lo svilimento, forse senza precedenti, della condizione umana.
5. Ma a questo punto, si pone un problema preliminare di grande portata: se necessariamente le "esortazioni" del Papa rinviano a un' analisi implicita, quale loro necessaria premessa, è possibile individuare delle fonti che, per la loro notorietà e connessione logica, siano da porre, altrettanto necessariamente e per obiettiva coerenza delle premesse rispetto alle conclusioni ("grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita"), alla base di questa analisi?
A ben vedere, tuttavia, questo interrogativo presuppone, con un'evidenza che non dovrebbe sfuggire, la risoluzione di una questione ancora più preliminare: perché l'analisi che costituisce la premessa delle affermazioni papali non è esplicitata? E ciò, con il rischio di indebolire una denuncia senza l'indicazione dei "denunciati" e, quindi, di farla apparire come un appello genericamente rivolto contro gli effetti ma, in pratica, vanificabile nel suo impatto sulle cause?
6. Alla possibile individuazione di fonti e fatti, sociali e culturali, che possano logicamente asseverare le conclusioni del Pontefice, dedicheremo un prossimo post.
Per risolvere la questione ulteriormene e preliminarmente anteriore sul "perché" della non esplicitazione, ricorreremo, invece, allo sviluppo che ci hanno fornito i commenti al precedente post.
Cominciamo, (come sovente capita) da questo scambio tra Sofia (1) e Arturo, che ci mette sulle "tracce":
![]()
Cercheremo allora di derivare da questi due interventi delle spiegazioni semplificate e basate su dei fatti oggettivamente evidenti, in modo da (almento tentare di) evitare quella complessità che aiuta molto l'intellettualità di cui si nutre il controllo culturale delle oligarchie, in quanto rende impenetrabile ai più il senso sostanziale delle giustificazioni degli slogan che la "gente" accetta così più facilmente, "fidandosi" più dell'autorità morale e culturale di chi porge questa complessità che della comprensione diretta dei problemi e, in tal modo, accettando degli slogan che riposano esclusivamente sulla loro provenienza e, quindi, su un implicito o esplicito, atto di fede" (e di pigrizia culturale che è un effetto deliberatamente perseguito dalle elites nell'epoca del tecnicismo pop).
7. Le spiegazioni in questione possono così essere riassunte:
a) il Papa è, per pacifico fatto notorio e istituzionalmente rilevante anche sul piano del diritto internazionale, il capo di un'organizzazione (a carattere religioso, ovviamente) presente nei territori statali della gran parte del mondo e che assume anche la qualificazione, per una sua proiezione, di soggetto di diritto internazionale. Ma a duplice titolo, di Santa Sede e di Città del Vaticano:
"Dal punto di vista di diritto internazionale, la Santa Sede è un'entità distinta dallo Stato della Città del Vaticano, che è il territorio di 0,44 km² su cui la Santa Sede esercita la sovranità.
Lo Stato della Città del Vaticano ha natura di Stato patrimoniale con la finalità di dare indipendenza e sovranità alla Santa Sede e ha quindi funzione strumentale alla missione della Santa Sede. La sua sovranità è dunque limitata.[3][4]
Le ambasciate estere, infatti, sono accreditate presso la Santa Sede e non presso lo Stato della Città del Vaticano, poiché quest'ultimo non gode di piena sovranità internazionale.
La Santa Sede gode della sovranità nelle relazioni internazionali quale caratteristica relativa alla sua natura in conformità alle sue tradizioni e alle richieste della sua missione. La minima base territoriale è detta necessaria per garantire una sufficiente autonomia dei suoi organi istituzionali.
L'Italia, in forza dell'articolo 3 del Trattato Lateranense stipulato nel 1929, riconosce alla Santa Sede la «piena proprietà esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana» sulla Città del Vaticano.[3]
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione italiana la situazione giuridica della Santa Sede è espressa in questi termini:
5. Ma a questo punto, si pone un problema preliminare di grande portata: se necessariamente le "esortazioni" del Papa rinviano a un' analisi implicita, quale loro necessaria premessa, è possibile individuare delle fonti che, per la loro notorietà e connessione logica, siano da porre, altrettanto necessariamente e per obiettiva coerenza delle premesse rispetto alle conclusioni ("grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita"), alla base di questa analisi?
A ben vedere, tuttavia, questo interrogativo presuppone, con un'evidenza che non dovrebbe sfuggire, la risoluzione di una questione ancora più preliminare: perché l'analisi che costituisce la premessa delle affermazioni papali non è esplicitata? E ciò, con il rischio di indebolire una denuncia senza l'indicazione dei "denunciati" e, quindi, di farla apparire come un appello genericamente rivolto contro gli effetti ma, in pratica, vanificabile nel suo impatto sulle cause?
6. Alla possibile individuazione di fonti e fatti, sociali e culturali, che possano logicamente asseverare le conclusioni del Pontefice, dedicheremo un prossimo post.
Per risolvere la questione ulteriormene e preliminarmente anteriore sul "perché" della non esplicitazione, ricorreremo, invece, allo sviluppo che ci hanno fornito i commenti al precedente post.
Cominciamo, (come sovente capita) da questo scambio tra Sofia (1) e Arturo, che ci mette sulle "tracce":
sofia13 dicembre 2015 11:43
Vedo che un'altra SOFIA interviene sul blog, ma mi pare di capire che la pensiamo allo stesso modo. I Papi non sono certo sottratti alle influenze liberiste ed anzi, hanno contribuito non poco a plasmare le menti anche di questa grossa fetta di mercato (quella dei cattolici). In un post (che magari Quarantotto pubblicherà) ho evidenziato che già (nei punti 42, 43, 58) della enciclica Centesimus Annus del 1991 Giovanni Paolo II sosteneva che il sistema economico vincente è quello “ di mercato “. E le stesse considerazioni si trovano anche nella eciclica Sollecitudo Rei Socialis del 1987. Quanto a Francesco, non è certo un caso che nel Conclave per la sua elezione, i voti sud-americani si sono sommati alla "massa critica" statunitense, e le tre americhe si siano unite dando una svolta al Conclave.

7. Le spiegazioni in questione possono così essere riassunte:
a) il Papa è, per pacifico fatto notorio e istituzionalmente rilevante anche sul piano del diritto internazionale, il capo di un'organizzazione (a carattere religioso, ovviamente) presente nei territori statali della gran parte del mondo e che assume anche la qualificazione, per una sua proiezione, di soggetto di diritto internazionale. Ma a duplice titolo, di Santa Sede e di Città del Vaticano:
"Dal punto di vista di diritto internazionale, la Santa Sede è un'entità distinta dallo Stato della Città del Vaticano, che è il territorio di 0,44 km² su cui la Santa Sede esercita la sovranità.
Lo Stato della Città del Vaticano ha natura di Stato patrimoniale con la finalità di dare indipendenza e sovranità alla Santa Sede e ha quindi funzione strumentale alla missione della Santa Sede. La sua sovranità è dunque limitata.[3][4]
Le ambasciate estere, infatti, sono accreditate presso la Santa Sede e non presso lo Stato della Città del Vaticano, poiché quest'ultimo non gode di piena sovranità internazionale.
La Santa Sede gode della sovranità nelle relazioni internazionali quale caratteristica relativa alla sua natura in conformità alle sue tradizioni e alle richieste della sua missione. La minima base territoriale è detta necessaria per garantire una sufficiente autonomia dei suoi organi istituzionali.
L'Italia, in forza dell'articolo 3 del Trattato Lateranense stipulato nel 1929, riconosce alla Santa Sede la «piena proprietà esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana» sulla Città del Vaticano.[3]
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione italiana la situazione giuridica della Santa Sede è espressa in questi termini:
« Alla Santa Sede, nella quale si concentra la rappresentanza della Chiesa cattolica e dello Stato della Città del Vaticano, è stata riconosciuta la soggettività internazionale ad entrambi i titoli e quest'ultima non è venuta meno neppure nel periodo in cui era cessata la titolarità di qualsiasi potere statuale. » (Cass., S.U., 18 dicembre 1979, n. 6569)
b) In secondo luogo, il patrimonio della Santa Sede, cioè l'ambito delle proprietà di cui è titolare l'organizzazione ecclesiastica retta dal Papa, al di là delle sue proiezioni giuridiche di diritto canonico e internazionali, è certamente di grande rilevanza. Esso fa capo all'APSA:
"L'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.) è l'organismo della Santa Sede che si occupa della gestione del suo patrimonio economico.
Venne istituita da papa Paolo VI il 15 agosto 1967 con la costituzione apostolicaRegimini Ecclesiae universae in sostituzione di due precedenti uffici, l'Amministrazione dei beni della Santa Sede e l'Amministrazione speciale della Santa Sede.
Successivamente papa Giovanni Paolo II, con la costituzione apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988, ha emanato nuove disposizioni riguardo al funzionamento dell'amministrazione...
L'ufficio ha lo scopo di amministrare i beni della Santa Sede e fornire i fondi necessari al funzionamento della Curia romana. È da considerare come la banca centrale della Santa Sede anche se spesso questo ruolo è erroneamente assegnato all'Istituto per le opere di religione.[2]
L'attuale presidente è il cardinaleDomenico Calcagno, nominato da papa Benedetto XVI il 7 luglio 2011.
Era strutturata in due sezioni, l'ordinaria e la straordinaria, con differenti funzioni:
- la Sezione straordinaria amministra i beni finanziari trasferiti dallo Stato Italiano in base alla Convenzione finanziaria allegata ai Patti lateranensi, quelli affidati da altri enti della Santa Sede, nonché altri fondi acquisiti successivamente; è lo strumento di contatto della Santa sede con le istituzioni finanziarie internazionali e con il sistema bancario;
- la Sezione ordinaria curava gli aspetti pratici di gestione, il bilancio, gli acquisti, le risorse umane, il CED e l'ufficio legale della Santa Sede, oltre a gestire i fondi necessari al funzionamento dei differenti dicasteri della Curia romana.
Nel luglio 2014 un motu proprio di Papa Francesco ha trasferito le funzioni della sezione ordinaria alla Segreteria per l'economia, costituita nel febbraio precedente, lasciando all'Apsa le funzioni più squisitamente finanziarie[3].
Emette moneta metallica, dal 01/01/2002 in Euro con valore legale e quindi in quanto monete con potere liberatorio limitato in tutta l'area dell'Euro."
c) Limitandosi dunque al patrimonio centrale della Santa Sede, cioè facente capo all'organizzazione di vertice sotto l'autorità giuridica e politica diretta del Papa medesimo, si avrebbe una stima di beni patrimoniali per circa 10 miliardi; da ciò andrebbe esclusa, si noti bene, una difficile integrale valutazione dell'oro depositato in varie istituzioni bancarie estere, e del patrimonio, certamente collegato agli scopi del magistero ecclesiale, di Propaganda Fide (ribattezzata Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, ha un patrimonio stimato, al netto della crisi immobiliare, di circa 7 miliardi);
d) A questo patrimonio "centralizzato", deve aggiungersi, in base al principio di sussidiarietà, quello delle diocesi e delle Conferenze episcopali nazionali, di ogni parte del mondo, che, secondo il diritto canonico hanno una titolarità proprietaria e gestionale autonoma dalla Santa Sede.
Ma, nondimeno, tutto questo complesso di beni, dovrebbe confluire nella sana gestione posta al servizio degli scopi spirituali del Magistero ecclesiale, inteso nella sua realtà ecumenica e quindi finalizzata a uno scopo "religioso" unitario.
Un sunto di questa articolata realtà giuridico-patrimoniale a fini unitari la traggo da questa fonte ufficiale (perdonate gli eventuali errori di carattere tale essendo il testo rinvenuto in rete):
"Sul piano tecnico-scientifico per comprendere la disciplina dei beni materiali nella Chiesa, bisogna tenere presente che si tratta di una materia con un profilo giuridico ed uno economico, ciascuno con propri principi e criteri, armonicamente articolati ma diversi.
Il profilo giuridico riguarda la realizzazione della giustizia, il rispetto dei diritti, le garanzie sul corretto uso dei beni per le finalità che sono proprie della missione della Chiesa. E' di questo che ci occuperemo soprattutto in queste lezioni.
Spetta invece all'economia stabilire le regole per un'adeguata gestione del patrimonio, al fine di ottenere da esso il maggior rendimento e la sua migliore applicazione alle stesse finalità della Chiesa.
Le esigenze di giustizia che si basano sul Diritto naturale o divino positivo (per es. i fini del patrimonio ecclesiastico, il rispetto della volontà del donante, ecc.) devono prevalere sui motivi di carattere economico; mentre le materie che sono, in quanto tali, indifferenti per la giustizia, dovranno essere regolate sulla base di criteri di efficacia economica opportunamente stabiliti da norme di diritto umano. Economia e diritto non soltanto non si oppongono; anzi, il giusto impiego dei beni richiede una adeguata gestione economica delle risorse.
3. Concetto unitario di patrimonio ecclesiastico: fini
L'espressione patrimonio ecclesiastico è utilizzata dalla dottrina canonica per designare l'insieme dei beni temporali della Chiesa; tuttavia, nè il nuovo CIC nè quello precedente adoperano questa nozione giuridica per riferirsi ad essi ma preferiscono fare riferimento in genere ai beni ecclesiastici o ai beni temporali della Chiesa.
Il patrimonio della Chiesa, infatti, non è riunito sotto l�unica e diretta titolarità dell'ente Chiesa universale, ma è diviso nei diversi patrimoni delle persone giuridiche ai cui fini e attività specifici sono finalizzati in maniera immediata. Come è stato ribadito, non vi � nessun bene il cui titolare diretto sia la Chiesa universale[2], perciò il can. 1257 � 1, nello stabilire quali sono i beni ecclesiastici non si riferisce solo ai beni della Chiesa universale, ma anche a quelli della Sede Apostolica (soggetto di diritto ex ipsa ordinatione divina: can. 113 � 1) e delle altre persone giuridiche pubbliche della Chiesa."
e) Il Sole 24 ore ci dà questa stima complessiva del vasto arcipelago del patrimonio ecclesiastico nel mondo:
Il suo patrimonio mondiale è fatto di quasi un milione di complessi immobiliari composto da edifici, fabbricati e terreni di ogni tipo con un valore che prudenzialmente supera i 2mila miliardi di euro. Può contare sullo stesso numero di ospedali, università e scuole di un gigante come gli Stati Uniti. Ha oltre 1,2 milioni di "dipendenti" e quasi un miliardo e duecento milioni di "cittadini".
Questo Paese immaginario dotato delle infrastrutture di un big dell'economia occidentale e della popolazione della Cina va sotto il nome di Chiesa. Un universo dietro al quale non c'è solo e unicamente il Vaticano, ma una galassia di satelliti fatta di congregazioni, ordini religiosi, confraternite sparse ovunque nel mondo che, direttamente o attraverso decine di migliaia di enti morali, fondazioni e società, possiedono e gestiscono imperi immobiliari immensi che nessuno forse è in grado di stimare con precisione e che sono sempre in costante metamorfosi.
Un patrimonio dove l'elenco dei beni, la maggior parte sicuramente no-profit ma una discreta fetta anche a fini commerciali, sembra non esaurirsi mai: chiese, sedi parrocchiali, case generalizie, istituti religiosi, missioni, monasteri, case di riposo, seminari, ospedali, conventi, ospizi, orfanotrofi, asili, scuole, università, fabbricati sedi di alberghi e strutture di ospitalità per turisti e pellegrini e tante, tantissime abitazioni civili in affitto. Un universo intorno al quale gravitano nel mondo 412mila sacerdoti e 721mila religiose – senza contare centinaia di migliaia di laici - che assistono 1 miliardo e 195 milioni di fedeli."
Un patrimonio dove l'elenco dei beni, la maggior parte sicuramente no-profit ma una discreta fetta anche a fini commerciali, sembra non esaurirsi mai: chiese, sedi parrocchiali, case generalizie, istituti religiosi, missioni, monasteri, case di riposo, seminari, ospedali, conventi, ospizi, orfanotrofi, asili, scuole, università, fabbricati sedi di alberghi e strutture di ospitalità per turisti e pellegrini e tante, tantissime abitazioni civili in affitto. Un universo intorno al quale gravitano nel mondo 412mila sacerdoti e 721mila religiose – senza contare centinaia di migliaia di laici - che assistono 1 miliardo e 195 milioni di fedeli."
8. Da quanto finora evidenziato, in termini peraltro schematici, e salva la possibile opinabilità delle stime (in pejus ma anche in melius, data la scarsità di dati disponibili complessivamente dotati di completezza e certezza), si possono però ragionevolmente trarre alcune considerazioni:
- il Papa, qualsiasi Papa (anche animato dalla più grande coerenza nel fornire un esempio pauperistico alla comunità mondiale dei fedeli e, in genere all'umanità intera), si trova inevitabilmente di fronte a un substrato materiale di imponenti accumuli di patrimonio e di ricchezza che, obiettivamente, è difficile controllare nella loro effettiva stima e , ancora di più, nella loro effettiva corretta gestione, coerente con la finalità strumentale di diffondere la fede e la dottrina cattolica. Un simile compito di reductio costante ad effettiva unitatem, risulta manifestamente impossibile.
- Quel che però è certo è che l'istituto della proprietàe, quelli ad essa strumentali, secondo i più diffusi, ordinamenti giuridici in tutto il mondo, cioè gli istituti giuridici di diritto pubblico e privato che prevedono i poteri gestionali di un tale patrimonio, corrispondono a un interesse essenziale della Chiesa: e questo, tra l'altro, dato che non esiste più un rilevante fenomeno di Stati "socialisti reali" che privano la Chiesa del diritto proprietario in modo prevalente e coessenziale, segnalandosi, questi Stati, come il principale nemico di fatto della stessa sopravvivenza organizzativa e funzionale della Chiesa stessa.
- La coesistenza tra questa enorme patrimonializzazione, le sue, spesso incontrollabili, esigenze di corretta gestione "economica"(espressamente enunciate a livello di diritto canonico), nonchè la programmatica esigenza di autoconservare e, possibilmente, estendere, l'elemento personale (tutti quegli ordini, congregazioni e diocesi e loro presidi territoriali, di cui parla il Sole 24 ore) e materiale della diretta organizzazione ecclesiastica, dunque, rendono la Chiesa direttamente interessata alla promozione di assetti istituzionali, in tutto il mondo, che si incentrino sulla tutela della libertà della proprietà e dei suoi strumenti di gestione contrattuale; una libertà possibilmente avulsa da ogni cenno di funzionalizzazionestatuale, cioè di necessaria strumentalità al servizio di interessi pubblici affermati dagli Stati ove si collocano gli stessi beni ecclesiastici (nella loro complessa articolazione di titolarità e gestione proprietaria).
- Se dunque esiste questo interesse di sopravvivenza, e la "funzionalizzazione" statale e costituzionale della proprietà è geneticamente avversa alla diversa funzionalizzazione enunciata dai canoni ecclesiali, di gestione e autoconservazione della propria esistenza e funzionalità (ai fini dell'esercizio mondiale del magistero), la Chiesa non può, per definizione, aderire ad una visione sociale e solidaristica pluriclasse degli istituti giuridici e delle politiche economiche quale affermata nelle Costituzioni interventiste e sociali.
Vi riporto a titolo di esempio particolarmente rilevante, trattandosi della Costituzione dello Stato italiano, nel cui territorio alberga una parte estremamente consistente del patrimonio della Santa Sede (comunque strettamente integrata, anche e proprio nella veste di Città del Vaticano, con quello dello Stato italiano, in base ai Patti Lateranensi), l'articolo 42 della Costituzione stessa:
Articolo 42
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
9. Dunque, la Chiesa, portatrice di una sua "superiore" funzionalizzazione di una vasta proprietà intrecciata con le sovranità statali-territoriali in tutto il mondo:
- avrà un interesse diretto a sostenere, da un lato, la mondializzazione (alternativa alla statualizzazione, "avversa" per definizione) della governance di queste stesse politiche economiche e giuridiche del regime complessivo della proprietà;
- dall'altro, sarà sempre portatrice di quella "paura" dei principi proprietari funzionalizzati all'interesse pubblico, affermata dagli Stati in chiave solidaristica e democratica sostanziale che, potenzialmente e anche praticamente (si pensi alle leggi sulla "manomorta" dell'ostile Regno piemontese unitario e alle riforme agrarie del secondo dopoguerra), sono visti come una minaccia alla propria esistenza.
Ora la posizione proprietaria, in termini gestionali e di conservazione contro ogni funzionalizzazione statale, è generalmente rafforzata dai trattati europei, come abbiamo visto quando si sono analizzati i fondamenti dell'economia ordoliberista anche in termini di morale cristiana, quali elaborati dal suo principale teorizzatore Roepke e dai suoi epigoni italiani, in primis Sturzo e De Gasperi (ampi ragguagli sul tema li troverete ne "La Costituzione nella palude").
I trattati sono infatti volti proprio alla destrutturazione di ogni forma di economia mista, interpretata come evoluzione ultima del collettivismo dannoso per i mercati e la loro libera e virtuosa formazione dei prezzi, e ciò da Roepke viene visto come riaffermazione delle stessa etica cristiana, che sarebbe inscindibile dalla piena libertà della proprietà privata (a cui, a rigore, eccettuato parzialmente quanto ambiguamente affermato dai Patti Lateranensi, bisognerebbe ascrivere, come avviene peraltro in gran parte del mondo, la proprietà a variegata titolarità giuridica dei beni ecclesiastici complessivamente intesi; secondo lo stesso diritto canonico).
10. E' allora più agevole comprendere, in questo contesto, perché l'analisi del Papa non sia esplicitata nelle sue premesse rispetto alle sue, pur drammatiche, conclusioni.
Uno status quo rafforzato dalla sterilizzazione dell'intervento statale nell'economia, incluso il fondamentale regime della proprietà privata, come quello promosso in crescendo dai trattati europei non può, per definizione, essere malvisto e criticato dalla Chiesa.
Questo status quo, - e abbiamo visto come la Santa Sede- APSA adotti persino l'euro come moneta di emissione-, non è facile da mettere in discussione: la funzionalizzazione statale minacciosa(che Dossetti esortava a superare, con argomenti del tutto dimenticati in sede ecclesiastica), della proprietà e dei suoi istituti di gestione, in funzione di un interesse pubblico necessariamente apprezzato dagli Stati a livello nazionale, costituisce un pericolo più immediato e tangibile di quello costituito dalle crescenti povertà e emaginazione di massa, provocate dalle politiche che le elites che gestiscono l'€uropa e, in generale, il new order mondialista dell'economia neo-liberista.
11. Anzi, la logica esplicita della complessa, ma finalisticamente unitaria organizzazione patrimoniale ecclesiastica, rende inevitabile un'ulteriore e obbligato sviluppo deduttivo: questa povertà e emarginazione sociali di massa, nella loro stessa esistenza, sono un oggetto di una condanna, da parte del cristianesimo in generale, e della Chiesa cattolica in particolare, che è sempre intrecciata con la funzione caritatevole e assistenziale che la Chiesa intende offrire e che giustifica la sua presenza nel mondo sul piano di un'azione materiale che viene considerata testimonianza di quella spirituale.
In base, però, al principio di sussidiarietà: cioè affidato a soluzioni, appunto caritatevoli e assistenziali su base volontaria, che reclamano la loro necessaria libertà da inquadramenti e obblighi sanciti normativamente dagli Stati.
E queste soluzioni si collocano sempre sul versante dell'intervento sugli effetti.
Mai su quello delle cause della povertà e della emarginazione, la cui estirpazione o correzione, non rientra negli scopi stessi del Magistero, come conferma l'incipit del paper di diritto canonico citato sopra:
"La Chiesa come società terrena e spirituale, ha bisogno di beni materiali per compiere la sua missione, infatti anche se il Regno di Dio non è di questo mondo, in quanto vive ed opera nel mondo è soggetto ai condizionamenti della vita terrena. "Le realtà terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite tra loro, e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misurache la propria missione richiede" (GS, 76).
Il Concilio Vaticano II ha voluto sottolineare, confermando il precedente magistero, quest'unione del celeste e del terreno nell'unica realtà della Chiesa pellegrinante (LG, 8), rifuggendo sia da un esagerato spiritualismo o pauperismo, sia dalla ricerca di un potere meramente terreno, fondato sull'influsso politico, economico o anche meramente umanitario: la missione propria che Cristo ha affidato alla sua Chiesa non è di ordine politico, economico o sociale: il fine, infatti, che ad essa ha prefisso è di ordine religioso.
Eppure da questa stessa missione religiosa scaturiscono dei compiti, della luce e delle forze, che possono servire a costruire e a consolidare la comunità degli uomini secondo la Legge divina. Così pure, ove fosse necessario, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, anch'essa può, anzi deve, suscitare opere destinate al servizio di tutti, ma specialmente dei bisognosi, ad esempio opere di misericordia o altre simili."
Insomma, in un modo o nell'altro, in questa teorizzazione, il presupposto dell'azione "eventuale" delle "opere di misericordia"è che i bisognosi ci siano. Non che, nell'instaurazione di un Regno di Dio che NON è di questo mondo, il bisogno sia estirpato o, almeno, che si debba tentare con ogni strumento di ottenere questo risultato. Appunto, "rifuggendo sia da un esagerato spiritualismo o pauperismo, sia dalla ricerca di un potere meramente terreno, fondato sull'influsso politico, economico o anche meramente umanitario: la missione propria che Cristo ha affidato alla sua Chiesa non è di ordine politico, economico o sociale".
(2- continua)