La risposta sintetica a queste domande, è che si voglia eliminare l'uso del termine"pubblico", in quanto si abbia la volontà di affermare la inadeguatezza, la insufficienzae la inefficacia(a fini da precisare), del regime di proprietà e di gestione pubblica di determinati beni che, - via via che si sono affermate le democrazie rappresentative e solidali-, erano ascritti alla sfera dello Stato o degli enti pubblici territoriali (cioè quelli che, comunque, nella Costituzione dello stesso Stato, trovano una disciplina di riconoscimento).Cominciamo con la disciplina della proprietà contenuta nella Costituzione, che trova la sua previsione fondamentale nell'art.42: "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità."
3. Come vedete, il concetto di "bene comune" non figura in Costituzione: la proprietà è o privata o pubblica, cioè intrinsecamente "comune" in quanto l'ente pubblico proprietario (a cominciare dallo Stato, come ci dice il primo comma), è considerato normalmente, e per via di altri fondamentali articoli della Costituzione, un'organizzazione comune "a fini generali", rappresentativa di una vasta comunità (identificata per lingua e tradizione culturale comuni, in relazione ad un determinato territorio ove ciò sia storicamente riscontrabile): vale a dire, lo Stato è l'ente (comune) rappresentativo del popolo italiano detentore della sovranità, popolo che la Costituzione si preoccupa di dichiarare "effettivamente" partecipante alla vita dello Stato, impegnando le istituzioni di indirizzo politico, a loro volta necessariamente rappresentative, a svolgere un'azione che ampli e garantisca nel tempo questa partecipazione effettiva. Il bene comune non statale, o comunque non appartenente ad un ente pubblico territoriale (esponenziale di una comunità che comunque si armonizza nel più ampio popolo sovrano, articolandosi in funzione di certe realtà territoriali considerate "naturali" e come tali riconosciute dalla Repubblica; cfr; art.5 Cost.),è dunque un bene privato.
Il regime della proprietà corrispondente alla legalità costituzionale è chiaro su questo punto.
4. Perché dunque si vuole sempre più utilizzare una categoria propria del regime dei beni privati per sostituirla a quella di "bene pubblico" (e al concetto di "interesse pubblico")?
La risposta più agevole è quella che si rivela dall'effetto sostitutivo appena descritto: al fine di poter affermare che una proprietà e una gestione private, di beni ascrivibili alle comunità territoriali, siano equiparabili a quelle pubbliche. Più precisamente, questa estensione di categorie del diritto privato pare rispondere all'esigenza di generare la convizione che sia indifferente, dato il mantenimento della qualificazione di "comune", che proprietà e gestione del bene, (in precedenza) gestito e utilizzato dallo Stato a favore della comunità dei cittadini, siano in mani pubbliche o private.
Il busillis va dunque spiegato cercando di capire cosa si voglia intendere per "comune", riferendolo al "bene" (cioè all'interesse generale perseguito da una comunità), o ai "beni" (cioè agli oggetti di proprietà, a fruizione o uso collettivo, pubblica o privata).5. In termini storico-giuridici, la principale fonte di questa aspirazione all'indifferenza terminologica tra "comune" (anche se a titolarità preferenzialmente privata) e pubblico, origina da dottrine provenienti dalla Chiesa.Sul "bene comune", inteso come aspirazione al benessere della collettività (sostitutivo dell'interesse pubblico), suggeriamo questa fonte riassuntiva contenuta nella Treccani.Andiamo per sommi capi, partendo dalla diatriba sull'obbligo, o meno, di lavoro dei monaci, che animò la rivalità tra "cluniacensi e cistercensi". Certamente, in assenza dello Stato di diritto in senso moderno, cioè di un'organizzazione comune a fini generali corrispondenti, nei suoi effetti obbligatori, al perseguimento dell'interesse indifferenziato di un'intera comunità territoriale, monaci che si attivavano per procurarsi i mezzi di sopravvivenza e rifiutavano di farsi servire dai "secolari" (essenzialmente servi della gleba, legati alla proprietà immobiliare posseduta dal monastero o ad esso affidata in base a regole canoniche o di diritto feudale, che lavoravano per i monaci o ad essi corrispondevano una "decima"), avevano una credibilità maggiore agli occhi dei potenziali donatori e autori testamentari:"Mentre la Regola di Benedetto affidava all’abate il possesso di tutti i beni (individuali e collettivi) con i quali questi doveva provvedere ai bisogni dei monaci, i cistercensi rifiutavano ogni possesso, persino quello di chiese e altari. La Carta caritatis, uno dei testi più significativi ai fini degli sviluppi del discorso economico successivo (la versione finale del testo risale al 1147), è su tale punto di una fermezza irremovibile (Stercal 2007; Zamagni 2009). Quale la conseguenza, certamente non voluta, né prevista, di tale duplice atteggiamento? Che lo stile di vita dei cistercensi, ben lontano dal lusso dei cluniacensi e improntato a rigore e povertà estrema, finì per attirare l’attenzione della gente che, persuasa del buon uso che delle liberalità costoro avrebbero fatto, inondò di donazioni i loro monasteri. Accadde così che, nel giro di pochi decenni, i seguaci di Bernardo si trovarono prigionieri della contraddizione che scaturiva dalla loro stessa spiritualità: vita sobria (e quindi bassi consumi) e lavoro produttivo – il sovrappiù agricolo che riuscivano a ottenere era superiore a quello realizzato nelle imprese tradizionali – avevano creato ‘l’imbarazzo della ricchezza’ (Milis 2002; cfr. Pacaut 1970, sulla vita all’interno dei monasteri cluniacensi e sulle difficoltà gravi che tale stile di vita andò a creare a partire dall’11° sec.)". 6. Ed è qui che, sempre prima dell'irrompere del concetto di Stato e della sua sottoposizione a norme vincolanti a provvedere al benessere della comunità, si colloca la novità e l'evoluzione storicamente legata al concetto di produzione e commercio:
"Ai francescani il merito di aver individuato la via d’uscita dall’imbarazzo della ricchezza con l’invenzione di quel modello di ordine sociale che sarà poi l’economia di mercato. Francesco, fondatore di un movimento eremitico, trasformatosi, con uno sviluppo folgorante, in ordine mendicante, recepisce da Bernardo sia il principio secondo cui i contemplantes devono essere anche laborantes, sia la regola per la quale i frati dovevano rinunciare anche alla proprietà comune. Se ne distacca però su un punto fondamentale: se si vuole trovare uno sbocco al sovrappiù generato in agricoltura e nella mercatura, e così superare l’imbarazzo della ricchezza, occorre dilatare lo spazio dell’attività economica facendo in modo che tutti possano almeno potenzialmente parteciparvi. Occorre cioè trovare il modo di far circolare la ricchezza prodotta, onde evitare che essa ristagni nelle mani di pochi. Come Giacomo Todeschini (2007) ha autorevolmente messo in luce, il convincimento in base al quale vi sarebbe un’insanabile inconciliabilità tra «economia di profitto» ed «economia di carità» è privo di solido fondamento. Ecco perché carità e profitto potevano apparire ai magistri francescani (Pietro di Giovanni Olivi, Bernardino da Siena, Bernardino da Feltre, Bonaventura da Bagnoregio, Guglielmo di Occam e altri ancora) e ai più attenti commentatori del modello della civiltà cittadina come le due facce della medesima realtà economica. Asse portante – anche se non unico – della civiltà cittadina è l’economia di mercato, intesa quale struttura di governo delle transazioni economiche (i mercati come luoghi degli scambi già esistevano in epoca greco-romana). I suoi tre principi regolativi discendono tutti, in qualche modo, dal pensiero francescano, prima vera e propria scuola di pensiero economico, come lo stesso Joseph Schumpeter ha riconosciuto nella sua monumentale History of economic analysis (1954). Due sono le novità che il francescanesimo introdusse nell’orizzonte culturale dell’epoca. La prima è che se usare dei beni e delle ricchezze è necessario, possedere è superfluo. Il che porta a concludere che «grazie alla povertà, poteva essere più facile usare e far circolare la ricchezza» (Todeschini 2004, p. 74). La seconda novità è che, se si vuole che la povertà come virtù possa essere concretamente praticata, è necessario che sia sostenibile, cioè possa durare nel tempo. Occorre dunque imparare a gestire il denaro, creando apposite istituzioni finanziarie". 7. Di questi problemi di origine, interna alla dottrina della Chiesa, della teorizzazione della "economia di mercato"abbiamo già parlato qui, con ampi approfondimenti nei commenti. Quello che più conta sono le conclusioni cui ci conduce la (autorevole) fonte qui adottata. Nelle successive elaborazioni, e nel confronto con l'inevitabile strutturarsi dell'economia mercantilista e, successivamente capitalista, il bene comune diviene una sorta di precondizione di conciliazione tra "economia di mercato" e elemento solidaristico; quest'ultimo, in essenza, è definito, a sua volta, da due elementi: la carità, cioè l'elargizione del minimo per la sopravvivenza a chi, per qualsiasi ragione ne sia privo, e la tendenza a temperare la spinta al profitto, cioè la facoltà attribuita a chi sia impegnato nella produzione e nello scambio, di non massimizzare il guadagno personale in funzione del riconoscimento di legami solidaristici con altri membri della propria sfera sociale di appartenenza.Entrambi questi elementi, come si può scorgere, al di là della loro funzionalità effettiva a massimizzare il benessere collettivo, si affidano però ad una volontà di "bene" (comune, cioè che riconosce l'altrui interesse come limite alla propria tendenza personale ed esclusiva all'accumulo di ricchezza), che nasce esclusivamente dalla coscienza e dalla spontanea adesione individuale. Non è prevista una regola che "imponga" di fare la carità e, specialmente, in quale misura, né esiste un obbligo giuridico (diremmo di diritto positivo) a limitare la spinta al profitto in funzione di legami comunitari e solidaristici. Nondimeno, su queste basi, di "coscienza" e di volontarismo spontaneo (che reggono sull'ipotesi di una comune etica cristiana, per di più intesa in un modo storicamente ben determinato, cioè proprio delle "correnti", prima cistercensi e poi francescane), si assume tutt'ora la possibilità di sostenere sia la preferenza per l'economia di mercato, sia la coesistenza immanente di questa col perseguimento del benessere collettivo.8. Il capitalismo persegue il "bene totale" e non il bene comune, e, in questo senso, va guidato e corretto in funzione di questa esortazione alla solidarietà volontaristica, ma, comunque ritenuta incoericibile, in base all'interferenza di regole dello Stato:"La concorrenza, attraverso il meccanismo emulativo, stimola la propensione a intraprendere e induce al calcolo razionale. Dove c’è concorrenza non ci sono posizioni di rendita e quindi privilegi di sorta. Certo, la concorrenza è costosa, ma migliora la qualità, perché induce a ‘individualizzare’ di più i prodotti; a conferire a essi un’identità. Come accade in politica, dove la democrazia comporta bensì costi elevati, ma evita il peggioramento della qualità del vivere civile. D’altro canto, come insiste con forza Bernardino da Siena nelle sue Prediche volgari del 1427, se il fine per cui si fa impresa è quello del bene comune, i costi sociali della concorrenza non saranno mai eccessivamente elevati. Nella predica XXXVIII, intitolata De’ mercanti e de’ maestri e come si deve fare la mercantia, si legge: «Per lo ben comune si die esercitare la mercantia» (Prediche volgari sul Campo di Siena, 1427, a cura di C. Delcorno, 1989, p. 1101) e più avanti: Cosa necessaria a una Città o Comunità si è che bisogna che vi siano di quelli che mutino [lavorino] la mercantia per altro modo; come s’è la lana che se ne fanno: lecito è che il lanaiolo ne guadagni. Ognuno di costoro possono e debbono guadagnare, ma pure con discrezione. Con questo inteso sempre, che in ciò che tu t’eserciti, tu non facci altro che a drittura. Non vi debbi mai usare niuna malizia; non falsar mai niuna mercantia, tu lo debbi far buono e, se non lo sai fare, innanzi la debbi lasciar stare e lasciarla esercitare a un altro che lo facci bene, e allora è lecito guadagno (p. 1138). Dunque, se il mercante usa la sua ricchezza in vista del bene comune, la sua attività è non solo lecita, ma virtuosa. Si rammenti che è a Bernardino da Siena che si deve la prima sistematica definizione di bene comune dal punto di vista economico (Bazzichi 2010)."9. In estrema sintesi fenomenologica, l'ipotesi che legittima il sostegno all'economia di mercato è dunque la "fraternità", intesa come patrimonio morale spontaneo della comunità e di ciascun individuo:"Non c’è modo più semplice per convincersi che il fine del profitto di per sé non è costitutivo dell’economia di mercato che quello di riferirsi agli scritti degli umanisti civili (da Leonardo Bruni a Matteo Palmieri, da Antonino da Firenze a Bernardino da Feltre) e agli autori dell’economia civile del Settecento (Antonio Genovesi, Giacinto Dragonetti, Cesare Beccaria, Pietro Verri, Giandomenico Romagnosi). La costante che ricorre in tutte le loro opere è che le attività di mercato vanno orientate al bene comune, dal quale solamente esse traggono la loro giustificazione ultima. Una delle prime trattazioni della nozione di bene comune è il De bono communi (1302) del domenicano fiorentino Remigio de’ Girolami. L’idea centrale che il testo sviluppa è che non si dà il bene della parte senza il bene del tutto in cui la parte è inserita: senza l’orientamento al bene comune, la società si distrugge e con essa i singoli individui (cfr. Bruni 2003 per una pregevole ricostruzione storica della nozione di bene comune come opposta a quella di bene particolare, dal Convivio di Dante a Francesco Guicciardini). Ma in cosa precisamente consiste la differenza tra bene comune e bene totale? Una metafora chiarisce il punto. Mentre il bene totale può essere reso con l’immagine di una sommatoria, i cui addendi rappresentano il bene dei singoli, il bene comune è piuttosto assimilabile a un prodotto, i cui fattori rappresentano il bene dei singoli. È chiaro il senso della metafora: in una somma se alcuni degli addendi si annullano la somma totale resta comunque positiva. Anzi, può addirittura accadere che se l’obiettivo è quello di massimizzare il bene totale convenga ‘annullare’ il bene (o benessere) di qualcuno a condizione che il guadagno di benessere di qualcun altro aumenti in misura sufficiente per la compensazione. Non così, invece, con un prodotto, perché l’annullamento anche di un solo fattore azzera l’intero prodotto. Detto in altri termini, quella del bene comune è una logica che non ammette sostituibilità: non si può sacrificare il bene di qualcuno – quale che ne sia la situazione di vita o la configurazione sociale – per migliorare il bene di qualcun altro e ciò per la fondamentale ragione che quel qualcuno è pur sempre un portatore di diritti umani fondamentali. Per la logica del bene totale, invece, quel qualcuno è un individuo, cioè un soggetto identificato da una particolare funzione di utilità e le utilità – come si sa – si possono tranquillamente sommare (o confrontare), perché non hanno volto, non esprimono un’identità, né una storia. Essendo comune, il bene comune non riguarda la persona presa nella sua singolarità, ma in quanto è in relazione con altre persone. Esso è dunque il bene della relazione stessa fra persone; è il bene proprio della vita in comune. È comune ciò che non è solo proprio – così accade invece con il bene privato – e ciò che non è di tutti indistintamente – così accade con il bene pubblico. La chiave attorno alla quale ruota il discorso sulla legittimità etica dell’attività economica di mercato è dunque la fraternità."
10. Questo insieme di lodevoli propositi, che certamente presuppongono una sforzo ideale e etico, constantemente ritrovabile nell'intera comunità sociale, (dato che la stessa teoria postula che se anche uno solo se ne tira fuori, rischia di azzerarsi il vantaggio di ogni possibile "bene comune"), viene dunque contrapposto all'interesse pubblico incarnato dalle norme dello Stato: inevitabilmente, se lo Stato limita il "libero mercato", da un lato nega la precondizione di diffusione del bene comune, dato che gli individui non potranno più liberamente esercitare la loro spinta solidaristica coessenziale all'iniziativa economica (secondo questa visione, ovviamente), dall'altro, disconosce il carattere esclusivamente privato, e funzionale al bene comune, della stessa illimitata disponibilità e trasmissione della proprietà mediante il "mercato" (se non altro lo Stato vorrà tassare e appropriarsi di una parte della proprietà delle ricchezza prodotta e deciderà di intestarsi alcuni beni per ragioni di interesse statale, stabilite da norme pubblicistiche).
Questi elementi, molto più del riscontro degli effetti storico-sociali concreti della teorizzazione, divengono il carattere fondante della teoria del "bene comune".
11. In questo concetto di bene comune, infatti, la scommessa etica della solidarietà insita naturalmente in ogni individuo impegnato a dar vita all'attività di mercato, è data come "vinta", per definizione, e lo Stato finisce per essere oggetto di una presunzione assoluta di intervento distorsivo. Tracce evidenti di questo ordine di pensiero le abbiamo in Roepke (ne trattiamo in "La Costituzione nella palude" pagg.185-186, nota 78) e, in generale, negli ordoliberisti a ispirazione cristiana (che, com'è noto, ammettono l'azione dello Stato in quanto garante e esecutore con regole di "polizia", del libero gioco del mercato e del sistema dei prezzi).
Traendo dalla fonte sopra citata (su relazioni tra "economia sociale di mercato" e dottrina sociale della Chiesa), si ha la conferma della piena attualità di questa visione in aderenza alle sue origini, ma pure della"realistica" consapevolezza, derivante dall'esperienza proprio dello svolgersi delle vicende storiche legate all'economica di mercato, del limite volontaristico, ineludibile, delle "personali" virtù umanistiche e solidaristiche, come tali incoercibili dallo Stato rispetto a qualsivoglia "individuo":
"Che cos'è il liberalismo?", si domanda il nostro autore (Roepke).
"Esso è umanistico. Ciò significa: esso parte dalla premessa che la natura dell'uomo è capace di bene e che si compie soltanto nella comunità, che la sua destinazione tende al di sopra della sua esistenza materiale e che siamo debitori di rispetto ad ogni singolo, in quanto uomo nella sua unicità, che ci vieta di abbassarlo a semplice mezzo. Esso è perciò individualistico oppure, se si preferisce, personalistico". Dalla definizione di Röpke emerge una nozione di liberalismo che lo sgancia da un'idea dogmatica e rigida dello stesso, evidenziando i connotati di un pensiero umanistico, in quanto non condivide né l'idea pessimistica hobbesiana di un uomo per natura egoista, né quella ottimistica di Rousseau. Il liberalismo di Röpke fa proprio il principio caro alla tradizione dell'antiperfettismo e del realismo cristiano, di Agostino, di Pascal, di Rosmini, di Sturzo, fino ad arrivare a Giovanni Palo II, per il quale l'uomo, benché tenda verso il bene è pur sempre capace di male. Esso è personalistico, poiché "in conformità alla dottrina cristiana, per cui ogni anima umana è immediatamente dinanzi a Dio e rientra in lui come un tutto, la realtà ultima è la singola persona umana non già la società, per quanto l'uomo possa trovare il proprio adempimento soltanto nella comunità". Esso, inoltre, è antiautoritario, rendendo a Cesare quello che è di Cesare, ma riservando a Dio ciò che qualifica il suo rapporto con l'Assoluto: per il cristianesimo è la coscienza individuale che giudica il potere e non viceversa; esso, dunque, rifugge da ogni forma di nazionalismo, razzismo e imperialismo; in breve, è universale. Allora, il liberale per Röpke è "l'avvocato della divisione dei poteri, del federalismo, della libertà comunale, delle sfere indipendenti dello Stato, dei ‘corps intermédiaires' (Montesquieu), della libertà spirituale, della proprietà come forma normale dell'esistenza economica dell'uomo, della decentralizzazione economica e sociale, del piccolo e del medio, della gara economica e spirituale, dei piccoli stati, della famiglia, dell'universalità della Chiesa e dell'articolazione".
...In questa prospettiva andrebbe considerato anche il suo profondo convincimento in ordine alla contiguità ideale tra liberalismo e cristianesimo. In uno dei suoi scritti più celebri afferma: "il liberalismo non è [...] nella sua essenza abbandono del Cristianesimo, bensì il suo legittimo figlio spirituale, e soltanto una straordinaria riduzione delle prospettive storiche può indurre a scambiare il liberalismo con il libertinismo. Esso incarna piuttosto nel campo della filosofia sociale quanto di meglio ci hanno potuto tramandare tre millenni del pensiero occidentale, l'idea di umanità, il diritto di natura, la cultura della persona e il senso dell'universalità". Per Röpke, l'eredità spirituale che il cristianesimo ha tramandato al liberalismo è rappresentata dalla difesa della dignità di ogni singola persona umana contro tutte le forme di statalismo. Il fatto che esistano correnti di pensiero che mettono in discussione tale eredità spirituale, sostenendo, sul versante religioso, l'incompatibilità del cristianesimo con il liberalismo e, sul versante laico, l'incompatibilità delle istituzioni liberali con la fede cristiana, sarebbe il frutto, rispettivamente, di un "moralismo ignorante" e di un "economismo ottuso": "Un moralismo dilettantistico nell'economia nazionale è altrettanto scoraggiante quanto un economicismo moralmente indifferente, e purtroppo il primo è diffuso quanto il secondo".
12. Riteniamo che siano ora chiarite origini e portata del concetto di "bene comune", e che quindi risulti verificato, nella coerenza del relativo pensiero, come esso sia alternativo e, in termini molto pratici, oppositivo a quello di interesse pubblico generale incarnato dallo Stato costituzionale democratico.
Questa concezione, incentrata sulla virtuosità etica (inevitabile) dell'economia di mercato, fornisce la naturale cornice concettuale del concetto di "beni comuni". In assunto, che verificheremo: il "bene comune" prescinde e si legittima indipendentemente dalla proprietà e dalla gestione pubblica, assoggettata a norme che ne garantiscano la rispondenza all'interesse pubblico (considerato un'interferenza inefficiente sul prodotto finale delle forze del mercato).
La proprietà privata del bene ad uso collettivo (cioè "comune), - per la sua natura di bene indivisibile o a causa della precedente regolazione statale che considerava prioritario l'interesse pubblico alla proprietà ed alla gestione del bene-, diviene superflua: quello che conta è l'attitudine solidaristica che, in base alla spontanea virtù dell'operatore privato, tale gestione può sviluppare.
Non si nasconde che tale virtù spontanea possa non esserci e che quindi qualche norma dello stesso Stato possa imporre dei limiti ad un uso volto esclusivamente alla massimizzazione del profitto nella gestione del bene comune; ma quello che, in questa visione, così spesso richiamata dalla politica e dalle giustificazioni del legislatore (essenzialmente dedicatori all'attuazione di direttive europee), assume carattere di gran lunga prevalente è la sottolineatura della inefficienza dello Stato, della sua corruzione e degenerazione morale e della conseguente maggior legittimazione morale dell'operatore privato sia a gestire con maggiori efficienza, "onestà" e trasparenza il "bene comune". Ovviamente, in questo caso, si parla degli ex beni pubblici, dato che i "beni comuni" già appartenenti naturalmente alla sfera del diritto privato, non avrebbero bisogno di questa dottrina e di queste premesse "etiche" per essere sottratti, quantomeno, alla gestione pubblica.
In tal senso la formale proprietà pubblica rimane un dettaglio secondario: l'importante è che la gestione sia stabilmente e senza possibilità di alternative affidata alle forze del mercato, cioè ad operatori privati.
13. A riscontro di questa sostanziale funzione del concetto di "bene comune", affermativa di un regime privato di gestione, al più volontaristicamente "temperato", riportiamo quanto ci illustra Pietro Folena in suo scritto del 2005. Parte da una spiegazione "didattica" del concetto di bene comune, (ricorrendo poi al ben noto esempio del pascolo ad uso civico ed ai problemi di reciproca limitazione dell'uso individuale consentito ai vari "legittimati"): "Il concetto di “beni comuni” (“common goods”), in economia, indica originariamente quei beni quali le risorse naturali (acqua, la fauna, ecc.) esauribili, ma dal cui sfruttamento nessuno può essere escluso. I beni comuni sono anche definiti più precisamente come “beni di proprietà comune” – il che non va confuso con la proprietà pubblica, cioè dello Stato o altra istituzione pubblica. Si tratta di una distinzione non secondaria, di cui parleremo più avanti, perché presuppone un diverso modello di gestione, al di là della “mera proprietà”. Il problema originario dei beni comuni era (ed è) quello di stabilire delle regole che permettessero lo sfruttamento tendenzialmente universale della risorsa prevenendone l’esaurimento."
Com'è evidente, la "proprietà comune" non va "confusa con la proprietà pubblica", e quel che è più importante è che è il "diverso modello di gestione, al di là della "mera proprietà".
14. Sulle modalità di gestione lo scritto ci spiega che ne esistono una "liberista" e una "statalista". La prima viene fatta oggetto di una critica, che riporterò solo in parte ma che appare piuttosto confusa, in quanto si incentra su obiezioni non più relative al bene ad uso collettivo o indiviso, ma a distorsioni normali della gestione di proprietà private individuali e, comunque, non risulta del tutto coerente con quanto viene poi affermato (a sostegno della teoria del "bene comune". cioè la "terza via", quella "migliore"):
"...Alla provocazione di Hardin si è risposto con la formazione di due scuole di pensiero. La prima, quella che chiameremo liberista, sostiene che la soluzione della tragedia va ricercata nel mercato. Privatizzare i beni comuni, si sostiene, costituisce un freno all’eccesso di sfruttamento. Riprendendo l’esempio del pascolo, si potrebbe privatizzare il terreno, magari dividendolo tra i diversi allevatori. Nessuno di loro, quindi, potrà depauperare le risorse dell’altro e il pascolo rimarrà in equilibrio. E’ facile però obiettare che nessuno assicura che tutti gli allevatori sfrutteranno la loro parte oltre il limite di sopportazione sistema-pascolo. Può al contrario accadere facilmente che uno di loro decida di farvi pascolare 100 capi. Per un breve periodo, fin quando il pascolo non si sarà esaurito, l’allevatore “rampante” guadagnerà dieci volte il profitto dei suoi concorrenti i quali, a loro volta, saranno indotti a comportarsi alla stessa maniera, distruggendo l’intera risorsa. La natura della proprietà, quindi, non pare essere un freno alla “cupidigia” dei singoli.
Inoltre c’è una questione che non viene affrontata: quando il terreno era un bene comune, in ogni momento un nuovo allevatore poteva decidere di farvi pascolare la propria mandria ma, una volta diviso tra gli allevatori originari, solo loro e i loro eredi potranno sfruttare l’erba che vi cresce. Del resto “privato” non è forse il participio passato di “privare”? Si potrebbe anche pensare che il terreno, stavolta indiviso, venga acquistato da una persona esterna al gruppo di allevatori, la quale potrebbe affittare per l’uso pastorizio a chiunque. In tal modo – sostiene la scuola liberista – il proprietario si comporterà in modo tale che il pascolo rimanga sempre florido, poiché esso è la sua fonte di profitto e sarà suo interesse evitarne il depauperamento. Evidentemente non si può pensare che il proprietario ceda gratuitamente l’uso della risorsa, poiché non guadagnandoci nulla sarebbe indotto a lasciarla deperire...
...La maggiore criticità attualmente è rappresentata dall’acqua, bene comune per eccellenza in quanto assolutamente indispensabile alla vita. Difatti, sebbene ovviamente nessuno abbia mai proposto la privatizzazione della risorsa in sé, i processi di privatizzazione che coinvolgono le reti idriche nei fatti compromettono lo status di bene comune: dove gli acquedotti sono stati privatizzati, infatti, la logica del profitto ha portato a consistenti aumenti delle tariffe, ad un peggioramento della qualità dell’acqua erogata, all’esclusione dei morosi e delle fasce sociali più deboli. Inoltre nei paesi più poveri l’accesso all’acqua è divenuto motivo di conflitti armati (“le guerre dell’acqua”).
15. Insomma, una volta privatizzato il bene, esso è in qualche modo di proprietà individuale e perde ogni connotato il problema della massimizzazione del bene collettivo: se si verificano gli inconvenienti che egli segnala, questi attengono ai normali problemi gestionali della proprietà privata e, in generale, ai c.d. "fallimenti del mercato". Si tratta in definitiva di un attacco alla funzionalità della proprietà privata operabile rispetto a qualsiasi bene suscettibile di utilizzazione economica in regime di mercato (problema che è proprio affrontato dal sopra citato, e dimenticato, art.42 Cost. che, infatti, affida alla legge dello Stato di assicurare la "funzione sociale" della proprietà).
Vediamo invece perché la proprietà e, quel che è più importante, la gestione pubblica non andrebbero più bene come rimedi ai fallimenti del mercato:
"La seconda scuola è quella che potremmo definire socialdemocratica classica. Essa sostiene che il bene comune va semplicemente statalizzato. Sarà infatti lo Stato a dare in concessione il pascolo ai diversi allevatori, in condizione di parità di accesso, o comunque lo sfrutterà per il bene di tutta la comunità. Non è forse lo Stato (almeno in un regime democratico) il più autentico rappresentante degli interessi generali? Vi sono molte ragioni per sostenere questa tesi, né è il caso qui di preoccuparsi di confutarla in nuce. E, tuttavia va rilevato come l’attuale crisi della democrazia rappresentativa, la sfiducia verso la politica di strati sempre maggiori della popolazione, la corruzione, e altri fenomeni degenerativi che in Italia abbiamo conosciuto fin troppo bene pongono qualche interrogativo sulla sufficienza di un controllo statale dei beni comuni. Né è possibile pensare che ognuno di questi possa essere efficacemente gestito attraverso concessioni che mettono in moto innumerevoli ingranaggi burocratici. La soluzione – che nasce dall’esperienza della democrazia partecipativa – come vedremo più avanti, è un’originale mix di autogoverno e socialdemocrazia. Una “terza via” tra il “privato” e lo “statale” che disegna una nuova idea di “pubblico” in cui lo Stato è uno degli attori, non l’unico".
16. Insomma, lo Stato democratico è in crisi "rappresentativa" per corruzione e altri fenomeni degenerativi. Quindi, non è più in grado di concedere "il pascolo" e garantirne l'uso collettivo in modo da non suscitare la "sfiducia" dei cittadini e senza "ingranaggi burocratici".
Fatta una ricognizione delle "criticità", poste da vincoli internazionali, che imporrebbero la privatizzazione dei servizi pubblici, inclusa sanità e istruzione, nonchè legate all'allargamento del concetto di "bene comune" ai beni immateriali (qui la spiegazione si fa confusa perché non si comprende più il confine con il "bene privato di pubblico interesse", che, un tempo, era il titolo di un intervento legislativo di tutela statale, ma che ora è affidato alla superiore volontà dei trattati internazionali free-trade, tra i quali viene citata anche la direttiva Bolkenstein), ci offre la soluzione:
"Si è detto che vi sono due modi “classici” per gestire i beni comuni: uno liberista e l’altro “statalista”. Ma l’esperienza della democrazia partecipativa, in particolare del bilancio partecipato, ci dà una terza possibilità: quella che prevede, accanto alle istituzioni pubbliche, comitati di cittadini e associazioni che dicano la loro sulle regole e sulle scelte concrete riguardanti la gestione del bene. Non si tratta di una novità tout court. Qualcosa di simile avveniva sin da Medioevo, soprattutto nei paesi anglosassoni, dove il concetto di “beni comuni” (i “commons”) ha valenza giuridica. Ma anche in Italia esiste una tradizione, che oggi va sotto il nome di “usi civici”. Terreni agricoli e pastorali che appartengono a comunità, gestiti da comitati di cittadini interessati al loro utilizzo, spesso in collegamento con l’istituzione del luogo. Un esempio sono le cosiddette “Regole trentine”, riformate in peius recentemente. Ad esempio, negli Ambiti Territoriali Ottimali per i servizi idrici, è possibile introdurre, accanto al comitato di gestione istituzionale, un comitato formato da cittadini e rappresentanti di associazioni con poteri effettivi di co-decisione. In tal modo il bene acqua cessa di essere un bene “statale” e ritorna alla sua natura di bene “comune”, “comunitario”.
17. La soluzione appare attraente: accanto agli enti pubblici (le istituzioni), si suggerisce l'arricchimento con la partecipazione attiva di "comitati di cittadini e associazioni" che dicano la loro sulle scelte relative alla "gestione del bene".
Ed è proprio questo il punto: se andiamo a vedere cosa è accaduto per i "servizi idrici", non è che poi, né le istituzioni che rimangono formali proprietarie del bene ad uso pubblico, nè questi comitati e associazioni, abbiano molta scelta.
La forma unica e obbligatoria di gestione del bene pubblico, nel caso l'acqua e le reti e le funzioni varie di pubblica utilità che si accompagnano alla loro distribuzione, è vincolata: l'affidamento a una società privata. Con tutti i problemi, segnalati dallo stesso Folena, di fallimenti del mercato e di "inefficienze" dettate dalla posizione naturale di monopolista "locale" acquisita dal gestore privato e, duque, di tendenza all'instaurazione di una rendita e di contrazione dei costi e della qualità del servizio.
Si verifica cioè nella sua sostanza, e senza differenziazioni rilevanti, esattamente la soluzione liberista che veniva poco sopra criticata: al riguardo basti vedere la disciplina via via introdotta durante gli ultimi anni.
18. Stabiliti gli ambiti territoriali ottimali per una gestione che, in assunto, consenta economie di scala nella gestione delle reti, si finisce per supporre (juris et de jure) che queste economie di scala ci siano e che i gestori privati, stimolati dagli enti istituzionali e dagli eventuali comitati e associazioni che compongono quella che si riduce ad essere una "stazione appaltante", siano effettivamente indotti a politiche di investimenti, manutenzione e trasparenza, nonché tariffarie, "solidali e umanitarie": cioè che appunto tengano conto della prefissazione, in sede di affidamento, di principi regolatori quali
• la prevenzione dell’esaurimento;
• il mantenimento della qualità originaria; • il mantenimento – o addirittura l’incremento – della disponibilità della risorsa, stante l’incremento demografico e dei consumi;
• l’accesso universale;
• la difesa della proprietà comune del bene.
Ebbene predeterminare in sede di affidamento queste condizioni, in realtà, consegue alla condizione di monopolista locale dell'affidatario, cosa che si avrebbe cioè immancabilmente in qualunque forma di privatizzazione della gestione, comunque la si voglia giustificare e denominare: tuttavia, il sistema complessivo di controlli pubblici è, esattamente come in qualsiasi privatizzazione, reso arduo dalla debole resistenza del settore pubblico alla "forza politica", derivante da quella economica, del gestore. Si privatizza e si espone il controllore pubblico al pericolo della capture, che contraddistingue tutte le forme di "regolatori" rispetto ai settori "privatizzati" e, comunque, tutti i regolatori "settoriali", come ci insegna l'esperienza, anche attuale, e, in ogni modo una sterminata letteratura giuridico-economica sul tema.
19. Insomma, quando si parla di beni comuni e di affidamento della loro gestione, si parla di monopoli naturali: la concorrenza all'atto dell'affidamento non elimina questo problema e neppure può eliminarlo una gestione partecipata in fase di determinazione delle condizioni di (obbligatorio) affidamento al settore privato.
Il privato, per quanto pressato da "associazioni e comitati", ed ammesso che questi abbiano un'effettiva attitudine a far rispettare le condizioni di interesse generale (dell'affidamento) più degli enti territoriali pubblici, i quali, almeno, hanno una responsabilità elettorale verso i cittadini interessati, dovrà agire secondo logiche economiche e di equilibrio aziendale: i profitti in qualche modo devono emergere per remunerare il capitale e indurre all'investimento almeno "lordo" (la manutenzione e l'operatività effettiva di funzioni come la depurazione delle acque, l'effettiva raccolta distinta tra acque meteoriche e acque di risulta fognaria, ecc.). La maggior efficienza di un monopolista privato, per quanto sottoposto a controllo istituzional-partecipativo, rimane pur sempre dubbia: di certo è indimostrato che sia superiore a quella ottenibile dagli organi tecnici pubblici che una volta gestivano senza problemi di "fallimento del mercato".
"Ho cercato di dimostrare che (a seguito di privatizzazioni e liberalizzazioni, ndr.)
(a) i cittadini in genere hanno guadagnato poco o nulla dalle privatizzazioni, (b) le fasce di utenti più povere hanno pagato prezzi più alti,
(c) i contribuenti ci hanno rimesso perché lo stato ha venduto a prezzi troppo bassi e in vari casi ha perso entrate,
(d) la produttività delle imprese non è aumentata significativamente,
(e) i maggiori beneficiari sono stati gli azionisti, gli intermediari finanziari, i consulenti (in una parola la City).
Mi sono anche occupato di privatizzazioni in Italia, in dieci edizioni del Rapporto sulla Finanza Pubblica e in altri interventi (tra i quali La sinistra e il fascino concreto delle privatizzazioni).
La mia lettura del caso italiano è che le cose qui sono andate anche peggio che in Gran Bretagna.
Sia i governi di centro-sinistra che quelli di centro-destra hanno cercato di fare cassa vendendo soprattutto banche, telecomunicazioni, autostrade, aziende del settore dell’energia, anche altro, ma con effetti del tutto irrilevanti o modesti sul piano dell’efficienza e del benessere degli utenti, e invece distribuendo rendite ad ambienti capitalistici più o meno parassitari.
Mi sono convinto, soprattutto studiando il caso Telecom Italia (in I ritorni paralleli di Telecom Italia), che la vera origine delle privatizzazioni non sia il liberismo, anche se ovviamente i miti della libera concorrenza hanno avuto un peso nella retorica, ma uno scambio fra rendite politiche e finanziarie.
La tesi che ho sostenuto (in Le privatizzazioni come mito riformista) è che in particolare la sinistra, oltre più ovviamente la destra, abbia cercato di accreditarsi presso i gestori della finanza offrendo loro in pasto delle attività perfette per montarvi operazioni speculative, garantite dalla dinamica nel tempo dei flussi di cassa. Il caso delle autostrade è in questo senso emblematico. Il rischio imprenditoriale è nullo, la rendita garantita, gli investimenti attuati minimi e neppure rispettati, le tariffe aumentano con e più dell’inflazione, il contribuente continua a farsi carico della spesa per la rete in aree meno ricche e più a rischio (vedi autostrada Salerno-Reggio Calabria e grande viabilità interregionale), mentre un ambiente imprenditoriale come quello dei Benetton e altri sono diventati dei concessionari, con tutto quello che questo implica di rapporti con la politica. In tutti i settori privatizzati le spese di ricerca e sviluppo sono diminuite, indebolendo il potenziale tecnologico. Più recentemente mi sono occupato della dimensione europea delle liberalizzazioni e privatizzazioni (ne L’esperienza delle privatizzazioni), in particolare di elettricità, gas, telefonia, giungendo a queste conclusioni per i quindici stati dell’Unione Europea prima dell’allargamento nel 2004: (a) soprattutto per l’elettricità le privatizzazioni hanno comportato aumenti dei prezzi per i consumatori; (b) la separazione delle reti dalla gestione (vedi Terna, Snam Rete Gas, ecc.) è spesso costosa e senza chiari vantaggi per la concorrenza; (c) l’introduzione della concorrenza peraltro ha mitigato ma non rovesciato in benefici mezzi questi effetti avversi; (d) indagini ufficiali dell’UE, come quelle di Eurobarometro, mostrano che i consumatori si dichiarano più soddisfatti nei paesi che hanno adottato meno le privatizzazioni; (e) dove c’è stata più privatizzazione è aumentato il numero di famiglie in difficoltà nel pagare le bollette.
Verso dove andiamo? Sono convinto, anche osservando l’esperienza degli Stati Uniti, che l’appetito illimitato del capitalismo finanziario, quindi il suo immettere nel gioco sempre nuove scommesse, condurrà alla privatizzazione dello stesso stato sociale, cioè sanità, istruzione, previdenza e persino assistenza; e forse anche di alcune funzioni classiche dello stato come difesa, ordine pubblico e giustizia. In altre parole lo scenario è quello dello “stato minimo”.
Le ragioni di questa tendenza, di nuovo, non hanno molto a che vedere con efficienza e competizione. Non esiste alcuna evidenza empirica che possa sostenere che in generale la gestione privata di ospedali, consultori, asili nido, scuole, università, pensioni, ecc. consenta abbattimenti di costi. Dove li si osserva sono dovuti, in generale, a riduzioni reali di stipendio dei dipendenti o a condizioni di lavoro peggiori, spesso con abbassamento conseguente della qualità delle prestazioni, oppure al ricorso a personale immigrato.
Ovviamente, nel settore pubblico, ad esempio nelle università, si annidano aree anche ampie di parassitismo sociale:ma sarebbe molto meno costoso, e quindi più produttivo, motivare i dirigenti e sensibilizzare gli utenti dei servizi pubblici, eliminando così questa patologia attraverso un maggiore controllo democratico e un management di qualità.
Viceversa, quello che ci attende è una tendenza a creare una “industria” della sanità, dell’educazione, della pensione complementare. Negli USA questi settori sono ben presenti in borsa o in altri circuiti finanziari, spremono alte rendite dagli utenti grazie al fatto che comunque, nonostante le apparenze, operano in mercati non competitivi, e soprattutto costituiscono formidabili lobby in grado di impedire, ad esempio, ad Obama di riformare efficacemente la disastrosa sanità statunitense.
Una volta che si creano gruppi che controllano i flussi di cassa derivanti dal controllo dell’energia, dell’acqua, della sanità, della previdenza, ecc., la stessa democrazia come la abbiamo conosciuta in Europa nella seconda metà del 900 è a rischio.
La capacità dei gruppi finanziari che controllano gli ex servizi pubblici di influire sui governi e sulle stesse opposizioni parlamentari diviene così formidabile che, di fatto, diventa impossibile tornare alla gestione pubblica. Semplicemente diventa più facile comprare i governi, i parlamentari, i giornalisti, gli economisti, e il dissenso viene emarginato. Il vero rischio delle privatizzazioni perciò non è la relativamente piccola perdita di benessere sociale (ma non trascurabile per i gruppi in fondo alla scala sociale), caso per caso, industria per industria, ma il rischio politico-economico per il sistema nel suo insieme. Questo aspetto è stato colto nell'ultimo scritto di Tony Judt, uno storico della New York University, recentemente scomparso. “Come nel diciottesimo secolo”, egli scrive, “così oggi: svuotando lo stato delle sue responsabilità e risorse, ne abbiamo ridimensionato la centralità nella vita pubblica. Ne risultano ‘comunità fortezza’, intese nelle varie accezioni dei termini: settori della società che considerano se stessi fondamentalmente indipendenti dai funzionari pubblici e dal resto della società. Se ci si abitua a trattare unicamente o principalmente con agenzie private, nel tempo la relazione con il settore pubblico perde di cogenza e significato. Non importa che il privato faccia le stesse cose, meglio o peggio, a un costo maggiore o minore. In ogni caso, si finisce per perdere il senso di fedeltà alle istituzioni e di comunanza con gli altri cittadini”.E’ un processo ben descritto da Margaret Thatcher in persona. “La società non esiste affatto”, ella scrive: “esistono solo individui, uomini e donne, e famiglie”.
Se non esiste la società, ma solo gli individui e uno stato che agisce da “guardiano notturno” (supervisionando da lontano attività alle quali non prende parte) che cosa ci tiene, e ci terrà, insieme? Abbiamo già accettato la formazione di polizie private, di servizi di posta privati, di agenzie private fornitrici dello stato in tempo di guerra e molto altro ancora. Abbiamo “privatizzato” esattamente quelle responsabilità che lo stato moderno aveva laboriosamente riunito sotto la propria cura nel corso del diciannovesimo e del ventesimo secolo, afferma sempre Judt.
La mia lettura di ciò che sta accadendo è quella di un rischio per la coesione sociale e per la qualità della democrazia.
E’ questo l’effetto generale della distruzione del faticoso compromesso raggiunto in Europa dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale fra la tendenza instabile e potenzialmente sempre autodistruttiva del capitalismo e un modo di produzione statale, che, con tutti i suoi limiti, sottrae una parte della società alle febbri speculative. In questo senso, il compromesso “socialdemocratico” europeo, il “modello sociale europeo” e la stessa costruzione dell’UE, nonostante ovviamente non siano un’alternativa al capitalismo, sono l’unica eccezione rimasta in campo al dilagare della finanza globale. Ed è un’eccezione oramai vicina ad essere travolta, anche per la fondamentale incomprensione di buona parte della sinistra europea dei processi in atto (quando non si tratta piuttosto di corruzione più o meno mascherata dei partiti e dei sindacati “riformisti”).
Dunque la mia lettura della recente crisi globale (in Antologia della crisi globale) pone la questione della modifica strutturale dei rapporti di forza fra lavoro e capitale al centro della spiegazione di ciò che sta accadendo, e che trova nelle liberalizzazioni e privatizzazioni un elemento costitutivo. Solo una soggettività politica molto determinata potrebbe a questo punto invertire il processo."



![]()



.svg/2000px-Government_surplus_or_deficit_since_2001_(piiggs_and_US).svg.png)















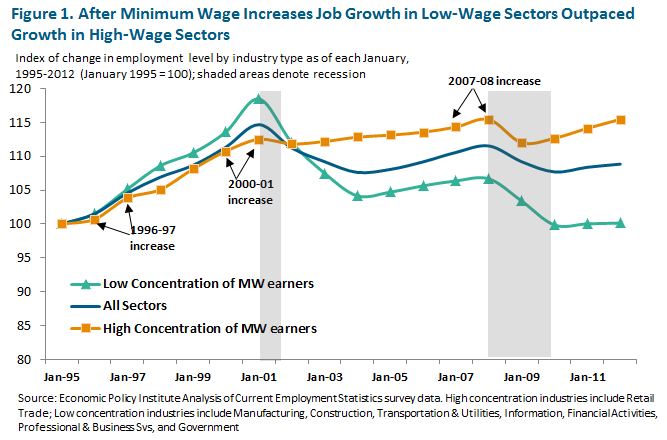


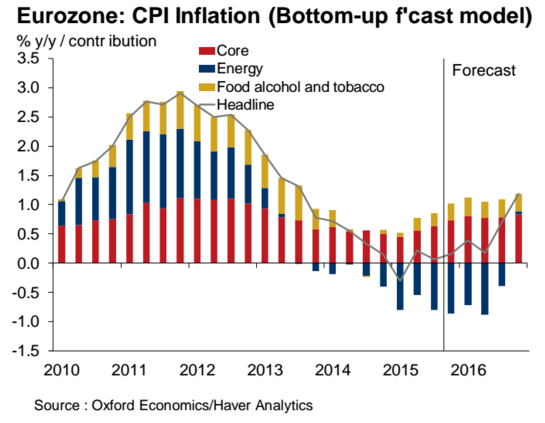



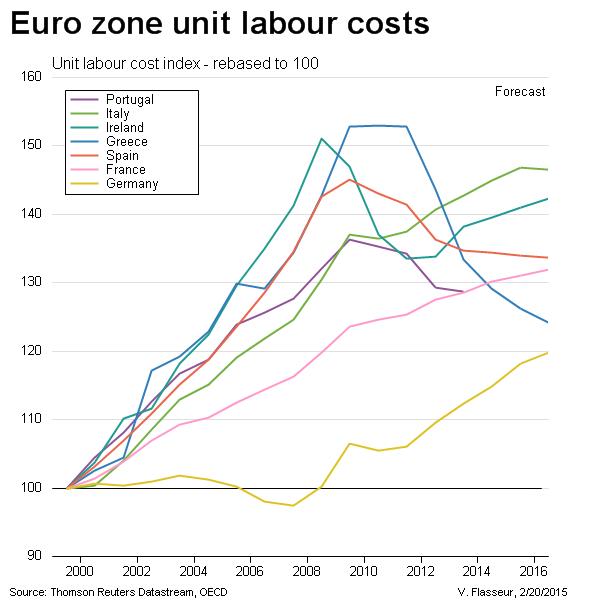






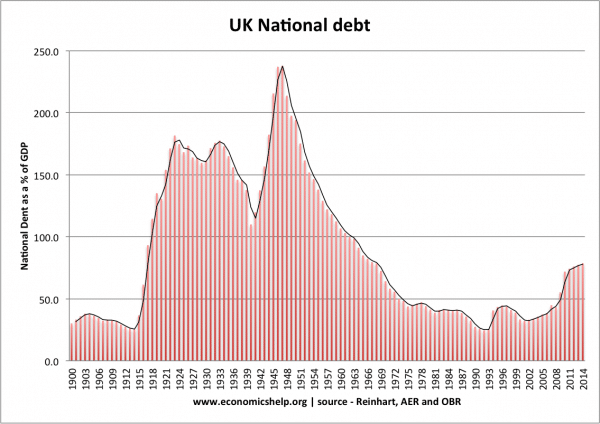
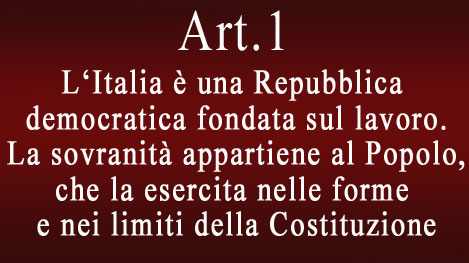




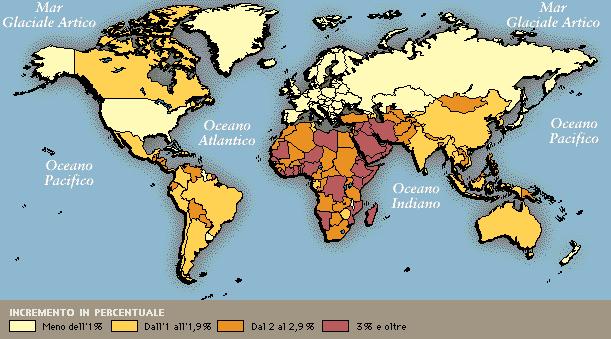
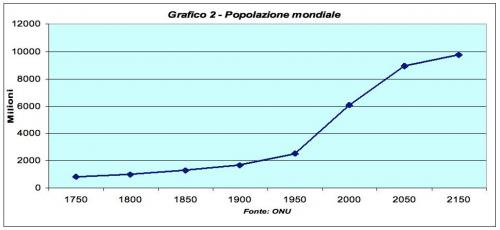
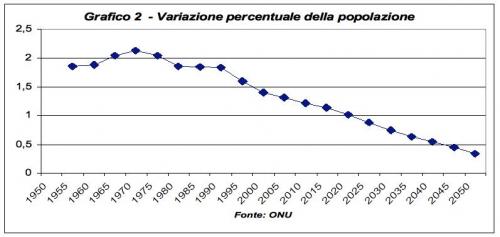

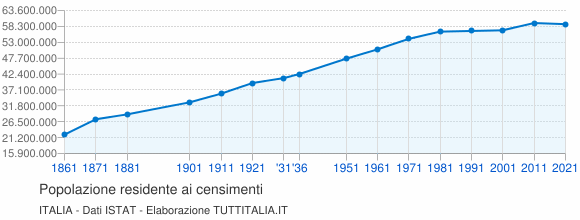

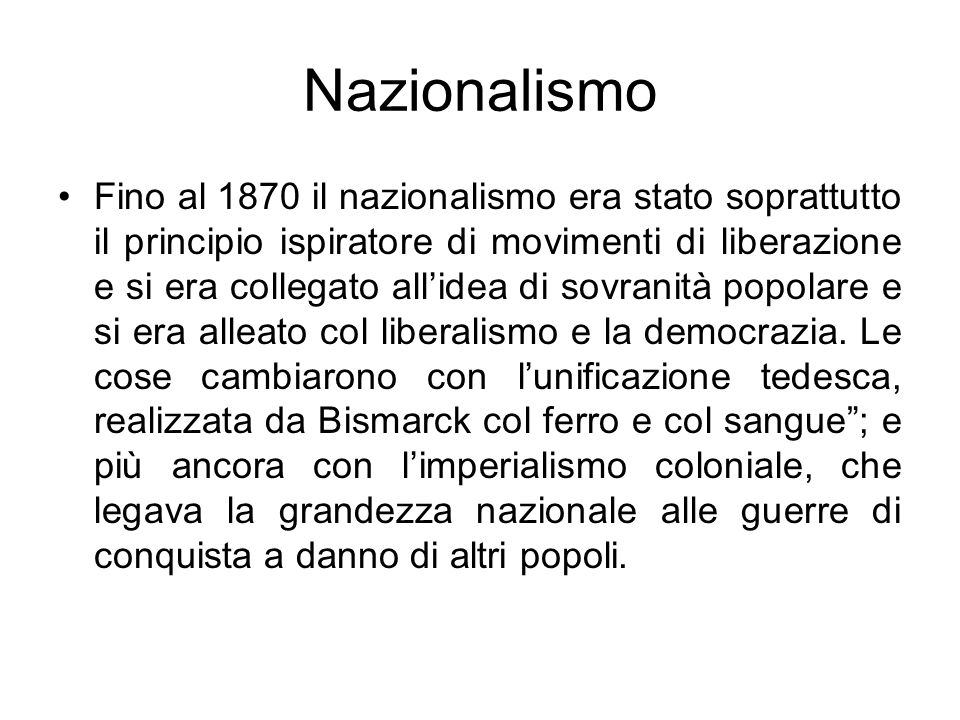
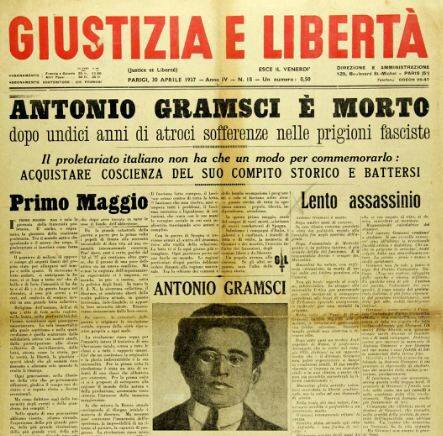
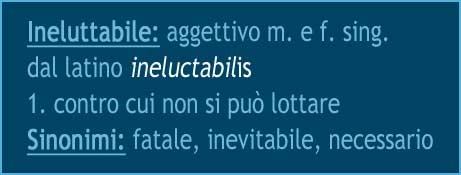

 Scopri le nostre collezioni dedicate alla Lira: riconiazioni degli esemplari più belli della Lira e le prime Banconote Coniate mai realizzate al mondo.
Scopri le nostre collezioni dedicate alla Lira: riconiazioni degli esemplari più belli della Lira e le prime Banconote Coniate mai realizzate al mondo. 
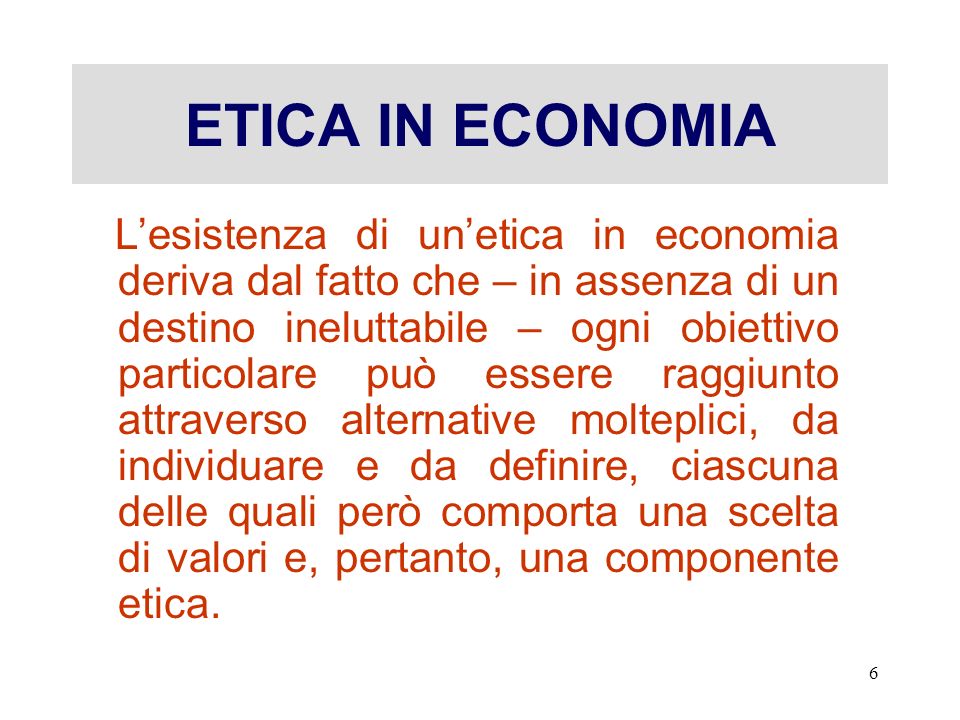








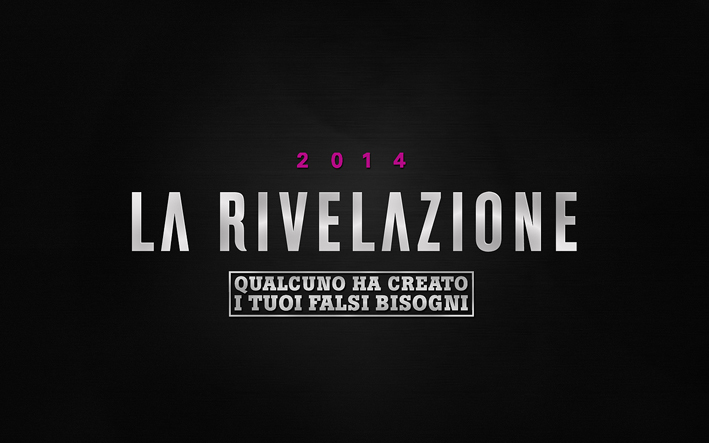 2014? E 2015, e 2016, e 2017, e 2018...ecc.
2014? E 2015, e 2016, e 2017, e 2018...ecc. 








